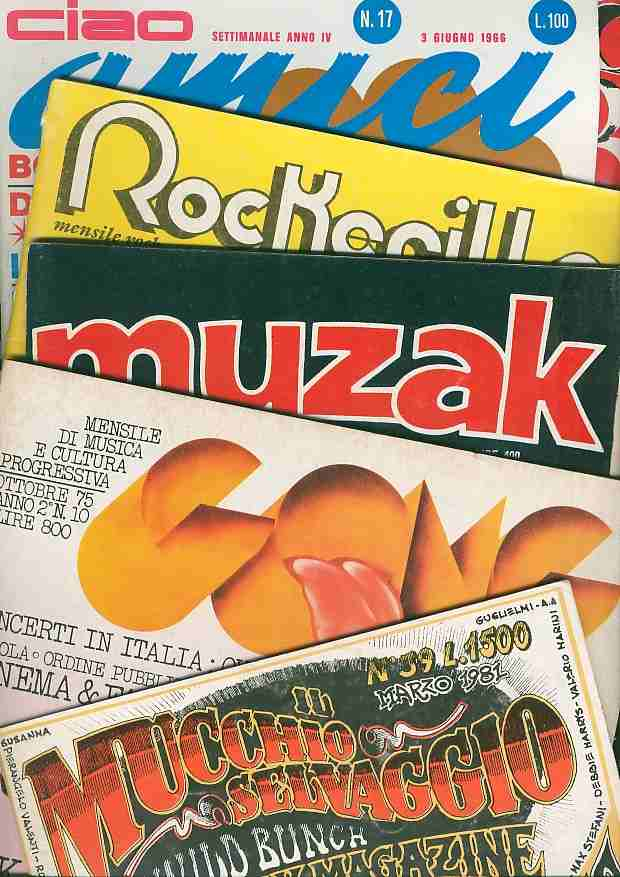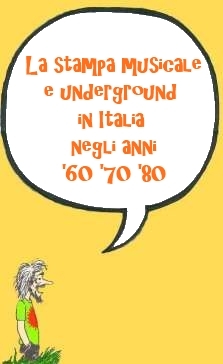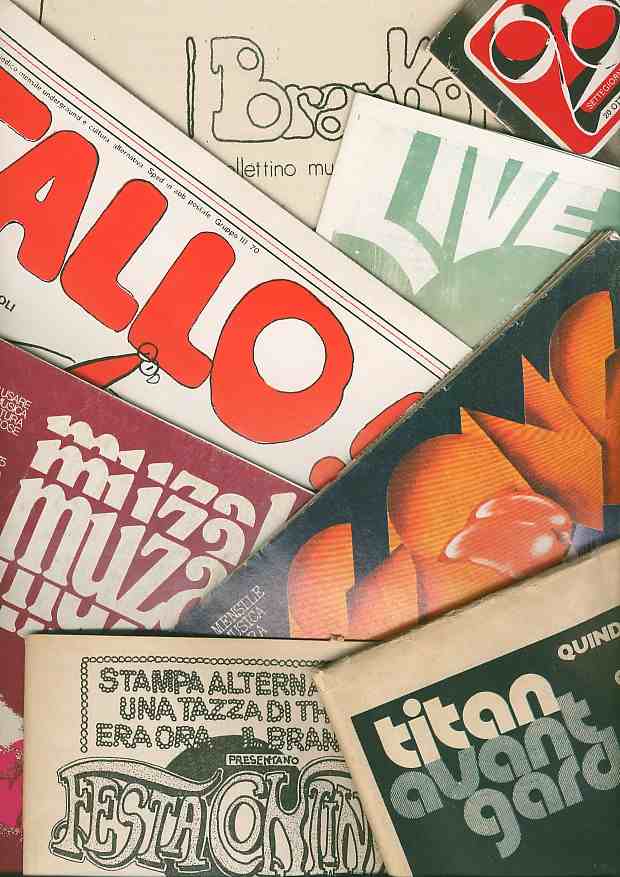|
|
 |
Il futuro della carta è
ora. Indagine sull'editoria musicale di casa nostra
A
cura di Maurizio Inchingoli
Tratta dal blog thenewnoise e risale al 5
aprile del 2017
Le
riviste rock escono ormai da cinquant’anni nel nostro Paese. Nei primi
anni Settanta spopolavano Ciao 2001, poi Gong, Muzak e Popster, Suono,
Tutto Musica, negli Ottanta si affermavano Rockerilla, Il Mucchio
Selvaggio, Musica 80, Buscadero, Rockstar, Velvet e Raro!, il decennio
fu forse il periodo d’oro dell’editoria del settore. Nei Novanta
arrivarono prima Rumore e poi Blow Up, Jam, le versioni italiane di
Rock Sound e Classic Rock, poi altre riviste di nicchia come Musiche,
Neural, Blast e Dynamo (su quelle metal, infine, si dovrebbe aprire un
corposo capitolo a parte, viste le peculiarità del linguaggio musicale
e visivo). Contestualmente, intendo fuori dalle edicole, nascevano e
morivano tutta una serie di piccole realtà underground come le fanzine,
e a elencarle tutte faremmo notte; in sostanza ci trovavamo di fronte a
numerose operazioni di diffusione sempre più capillare di musiche
alternative che successivamente, arriviamo ai Duemila, sarebbero
sfociate nelle webzine (pioniere nel bene e nel male della mastodontica
catalogazione online un certo Piero Scaruffi).
Torniamo
alla carta, supporto storicizzato e assimilato da più generazioni, che
ancora oggi fa la propria parte nella vita culturale del Paese,
purtroppo con cifre sempre più esigue in termini di vendita. Logico
pensare che un ventenne oggi non conosca quasi dei fogli stampati, data
la sua naturale propensione a fruire di contenuti culturali che passano
sotto-forma di pc, lettori mp3, tablet e smartphone. Lungi dal
sottoscritto fare le pulci sulle differenze che ci sono tra un
contenuto stampato e un altro di tipo digitale, viene comunque naturale
riflettere su dove stia andando l’editoria musicale di casa nostra e
come ci stia andando. I dibattiti sono numerosi e variano di interesse
a seconda dei soggetti che li intraprendono, specie su Internet, fermo
restando che più volte si nota una sorta di opposizione aprioristica
alla carta stampata, succede anche tra gli addetti ai lavori… I motivi
per criticare i giornali non mancano di certo, allo stesso tempo
risulta sin troppo facile sentirsi quasi à la page se si
dimostra alla propria cerchia di conoscenti, spesso più o meno
virtuali, di avere una posizione precisa e “contro”, ingenuo pensare di
trovare contenuti solo di qualità sul web, anzi, spesso succede
l’esatto contrario. Tuttavia, e non solo per una logica di equidistanza
critica, a sfogliare alcuni mensili viene il magone, davvero è facile
credere che a volte che chi le fa si rivolga a soggetti distanti anni
luce rispetto a quello che succede in giro, sul web o meno. A che punto
siamo arrivati, quindi? Qual è la situazione editoriale nel 2017? Come
stanno i giornali? Queste e altre domande mi sono posto, me le ponevo
da tempo per la verità… tanto da farmi venire la folle idea di
interpellare i diretti interessati. Sono riuscito a contattare i
direttori Stefano Isidoro Bianchi di Blow Up, Daniela Federico de Il
Mucchio Selvaggio e Rossano Lo Mele di Rumore, tre voci autorevoli,
altrettanti modi di vedere le cose allo stato attuale, coi quali sono
riuscito ad affrontare i vari argomenti anche in maniera schietta.
Avevo scritto poi alle redazioni di Rockerilla e Buscadero, i primi
hanno preferito non partecipare al dibattito, i secondi di fatto hanno
effettuato la stessa scelta, pur rendendosi all’inizio disponibili a
prendere parte al gioco. In un primo momento avevo pensato di
contattare pure Rolling Stone Italia, ma ho preferito circoscrivere
l’ambito di questa inchiesta alle sole riviste che sentivo più vicine
alla mia personale concezione della musica rock, non dimenticando il
bacino di lettori di New Noise. Tant’è, comunque vada ho provato a
togliermi qualche dubbio riguardo alla mia idea di editoria musicale
che mi ero fatto fino ad ora. Naturalmente a breve ci occuperemo anche
del web, per ampliare il respiro del discorso…
Stefano
Isidoro Bianchi - Blow Up
Alcuni lettori vi imputano il fatto di avere
tirato un po’ i remi in barca rispetto alle scelte editoriali di
qualche anno fa, alludo all’aumento delle copertine dedicate ai grandi
nomi del rock, di conseguenza a una parte dei contenuti. Posto che la
sola copertina non fa il numero, ovvio, e posto che io stesso rispetto
al 2010 non leggo più per intero Blow Up, prima leggevo perfino le
pubblicità… è lecito pensare che avete scelto un target di lettori più
adulti e che, come hai spiegato nel numero di marzo, vi rivolgete solo
a quelli che comprano le riviste, escludendo o dando per scontato che
non esistano più nuovi lettori?
Io
non do per scontato nulla al mondo, anche perché di lettori giovani e
giovanissimi ne abbiamo, solo che rispetto al passato sono sempre più
una minoranza. Quindi ti riformulo la domanda-risposta dicendoti che
sono soprattutto i lettori più adulti che leggono le riviste cartacee.
Ovviamente non ci rivolgiamo solo a loro, ma io mi baso sui fatti; e i
fatti (dalle ricerche di mercato ai contatti personali fino alla
semplice osservazione della realtà quotidiana) mi dicono che la
disaffezione nei confronti dei giornali investe soprattutto le
generazioni più recenti e, con esse, alcune categorie non censibili
anagraficamente come gli studenti o gli impiegati che lavorano
principalmente al computer (i quali sono portati per forza di cose ad
avere maggiore confidenza con la Rete rispetto a un medico, un
avvocato, un operaio, un professionista, un artigiano, un
commerciante). Ne discende che le edicole (ma anche i negozi di dischi,
le librerie e quant’altro) sono frequentate da clienti più “stagionati”
e che i giornali ne traggono le inevitabili conseguenze.
Ma
le copertine dedicate a musicisti “vecchi”, un fenomeno che, come sai,
investe tutte le
riviste musicali sia italiane che straniere, non è addebitabile
unicamente all’evidenza che i più giovani e/o gli impiegati si
informano e leggono soprattutto in Rete. Ci sono anche altri fattori,
diciamo più tecnici, che hanno portato alla latitanza di quelle figure
musicali intermedie che fino a una quindicina di anni fa permettevano
alle riviste specializzate di posizionarsi in maniera riconoscibile nel
mercato col lancio del nome underground “caldo”. Questo è dovuto
innanzi tutto alla biblica frammentazione dell’underground in mille
rivoli che non riescono più a comunicare tra loro e a fare “massa
critica”, e poi alla caduta della qualità media delle uscite
discografiche, fenomeno a sua volta dovuto in parti uguali al
vertiginoso abbassamento dei costi di produzione della musica (che
spinge chiunque a registrare e stampare qualunque cosa gli frulli per
la testa) e alla parallela mancanza di fondi per farlo bene, che ha
portato alla scomparsa di altre figure intermedie essenziali alla
realizzazione di dischi che abbiano quel minimo di caratteristiche
“professionali” (registrazione, mixaggio, produzione) da poter attrarre
anche il pubblico non specialistico. Una catena di eventi che, legati
l’uno all’altro, portano alla drastica assenza di questi musicisti
“intermedi”, costringendo le riviste a rivolgersi a nomi più popolari e
diffusi (dai Doors a Iggy Pop, da Jesus & Mary Chain ai Depeche
Mode, dai Pink Floyd agli Afterhours o ai Radiohead) perché sono
rimasti gli unici in grado di attrarre il pubblico che acquista
giornali in edicola. È una legge di mercato dalla quale nessuno può
chiamarsi fuori – e difatti nessuno se ne chiama fuori.
Ciò
detto, in realtà noi continuiamo a fare il nostro lavoro esattamente
come lo facevamo dieci e venti anni fa e chi legge il giornale senza
fermarsi alla homepage del sito sa bene che i materiali “nuovi” sono
sempre presenti in maniera consistente. Abbiamo stimolato il più
possibile gli abbonamenti (che sono arrivati a livelli inimmaginabili
per un cartaceo delle nostre dimensioni) e dal numero di aprile 2017
rinnoviamo il giornale con una diversa struttura delle recensioni e
nuove rubriche. Abbiamo spazi piuttosto rilevanti (almeno per una
rivista che si occupa principalmente di musica) dedicati a libri e
cinema e da oltre un anno pubblichiamo un trimestrale monografico
formato libro, Director’s
Cut, che regaliamo a tutti gli abbonati e che sta andando molto
bene anche con la distribuzione nelle edicole. Le cose insomma sono
sempre in movimento e io sono convinto che Blow Up sia molto più
interessante oggi di dieci e venti anni fa. Ciò detto, chi vive in Rete
e ha un immaginario fortemente legato ad essa fa bene a pensare che
abbiamo “tirato i remi in barca”, perché in un certo senso è vero: non
rincorriamo gli standard né scimmiottiamo le modalità della Rete perché
non siamo capaci di farlo. Cosa che, beninteso, per me non è un limite
ma un merito: a ciascuno il suo mestiere.
I freddi numeri: quante copie vendete al
mese più o meno e quanti abbonati avete? Rispetto a quando siete usciti
la prima volta in edicola, qual è stato l’anno col massimo di vendite?
Le
copie vendute in edicola attualmente girano intorno alle 3.500 (la cosa
si differenzia mese per mese), in più abbiamo oltre 1.000 abbonati (se
le altre riviste ti dicono che vendono di più sappi che, a parte il
Buscadero che sta sopra tutti, non è vero). Gli anni del maggior
venduto sono stati il 2004-2008 (circa 6.000 copie in edicola, però gli
abbonati allora erano più o meno 300).
Qualche anno fa mi raccontasti della tua
sfiducia nel web, che YouTube era una sorta di nuova tv e che anche
siti come Wikipedia sono stati capaci di pubblicare definizioni
inesatte (a volte è vero, purtroppo…). Continui a pensarla cosi? Non è
forse un caso che il vostro sito non abbia poi tanti contenuti. Devo
immaginare che quando andrete in pensione il giornale chiuderà?
Continuo
a pensarla così, anzi la mia convinzione si è rafforzata (YouTube è già
la nuova televisione generalista, Wikipedia te la raccomando) e mi pare
che le discussioni mediatico-politiche che hanno tenuto campo in questi
ultimi mesi (dalle fake news alle possibilità manipolatorie
dell’informazione che corre in Internet) mi abbiano dato ragione. Della
Rete non amo innanzi tutto l’anonimato degli hater e la violenza che
vomitano a getto continuo (ho letto cose su di me e su Blow Up che
sarebbero da denuncia), la superficialità e la disinformazione, i flame
improvvisi e le derive populiste, l’ideologia del nuovismo e – a
costo di apparire moralista – il pessimo messaggio educativo che
trasmette. Non si tratta però di avere o non avere sfiducia nel web,
che è solo uno strumento e come tutti gli strumenti può essere utile o
dannoso a seconda dei modi in cui lo si utilizza: un coltello in cucina
è utilissimo per tagliare la carne e affettare il pane ma può diventare
molto pericoloso se lo prende tra le mani un bambino. Aver lasciato
l’accesso completamente libero a chiunque e senza alcuna forma di
controllo non è affatto “democrazia” ma anarchia, perché la democrazia
si fonda su regole esatte che devono essere rispettate in maniera
ferrea, altrimenti la società degenera rapidamente nel dominio del più
forte, del più furbo e del più attrezzato, vale a dire l’esatto
contrario della democrazia (per comprendere bene il meccanismo della
comunicazione e di Internet è molto più utile leggere un classico come Psicologia Delle Folle di
Gustave Le Bon, datato 1895, che non le tante opere dei troppi esperti
e intellettuali che ne hanno scritto negli ultimi vent’anni).
Sarebbe
bastato (basterebbe) poco per trasformare una fogna in un canale pulito
e praticabile: obbligare l’accesso alla Rete attraverso un rigido
controllo dell’identità di chi naviga, esattamente come si fa con i
telefoni e le carte di credito. Ma fare così avrebbe limitato
(limiterebbe) la diffusione e la pervasività della Rete stessa, come
ben sanno le multinazionali della comunicazione e del divertimento che
sono riuscite nel paradossale capolavoro di far diventare paladini e
pasdaran della Rete proprio coloro i quali da essa hanno subito e
subiscono i maggiori danni (non è per caso, diciamolo, che gli uni sono
padroni e gli altri sudditi). Perché il meccanismo è così ovvio ed
evidente da essere banale: più scrivi in rete a qualunque titolo e in
qualunque modo e più diminuiscono le tue possibilità di fare della
scrittura un mestiere pagato (giornalista, scrittore, libraio), più
carichi e scarichi musica tua o altrui e più diminuiscono le tue
possibilità di fare della musica un mestiere pagato (musicista,
etichetta, negoziante), più carichi e scarichi film e più diminuiscono
le tue possibilità di fare del cinema un mestiere pagato (critico,
regista, attore). Sarà un caso che questi tre mestieri culturali, in
misure diverse, sono usciti così massacrati dall’avvento di Internet da
essere a rischio di estinzione? Tutte cose già dette e ormai digerite
da tempo, beninteso, ma ricordarle non fa mai male.
Nello
specifico musicale la mia sfiducia nacque (e persiste) allorché,
all’avvento di Internet, la gran parte di quanti avevano voce in
capitolo su quello che da subito apparve come uno dei settori a maggior
rischio tanto economico che estetico (più che altro giornalisti e
ascoltatori, ma anche etichette e musicisti di secondo piano) si
dichiararono entusiasti della novità che avrebbe portato la Rete – la
famosa libertà –
con la morte delle cattivissime major e l’auspicato dominio del DIY
quale approdo terminale a una sorta di paradiso in terra in cui i
musicisti si sarebbero gestiti da soli senza dover rendere conto a
nessun altro che a se stessi. Vedi un po’ com’è andata a finire: le
major, pur ridimensionate, continuano a dominare il mercato e le indie
rimaste in vita (non considero tali quelle che fanno pagare i musicisti
per stampargli i dischi né quelle che distribuiscono materiali free) non hanno più alcuna reale
capacità di penetrazione, mentre dal punto di vista estetico l’unico
modello che detta legge è quello dei talent show. Non un gran
risultato. Io scrissi il mio primo articolo in cui ponevo molti dubbi
sull’integralismo internettista nel maggio 1999, addirittura prima che
nascesse Napster, e ne faccio ancora una bandiera nonostante nel corso
degli anni mi sia beccato un bel po’ di accuse d’esser fascista,
retrogrado, antiquato e reazionario: in quest’ottica, tutti bellissimi
complimenti. Ma tant’è, ormai ci siamo dentro fino al collo e tanto
vale nuotare. Con Blow Up uso il web per le cose che si dimostrano
utili al giornale, quindi pubblicizzare le uscite mensili e facilitare
l’acquisto di abbonamenti, arretrati e libri, e non lo uso per quelle
che si dimostrano deleterie, quindi la pubblicazione di contenuti,
esclusivi o meno che siano. Il giorno in cui inserire contenuti sul
sito sarà utile al giornale ed economicamente sostenibile sarò il primo
a caricarne tonnellate.
Immagino che una sbirciatina su Internet
qualche volta la dai… Trovi comunque dei siti interessanti? Credi che
l’ibridazione delle due tecnologie, ad esempio una proposta tipo
cartaceo + web sia possibile o la trovi una sciocchezza?
Tutt’altro
che una sbirciatina, ci passo una buona dose di tempo non solo perché
il mio lavoro mi costringe a farlo ma anche perché per poter parlare di
qualcosa, nel bene e nel male, devi conoscerla. E conoscerla mi ha
portato a capire che l’ibridazione delle due tecnologie non solo era
plausibile ma anche stimolante e persino necessaria: come ti ho appena
detto nella precedente risposta, facilitare gli acquisti on line è
stato un vero toccasana. Per il momento però non credo che ci siano
altre percorribili ipotesi di ibridazione perché analizzando i dati
nudi e crudi vedo che l’interazione col web non porta alcun beneficio
alle testate derivate o emanazione della carta stampata. Quelle che
hanno siti sempre aggiornati con notizie e articoli non solo non ne
traggono alcun beneficio, ma al contrario ne sono penalizzate perché
vivono l’ovvia contraddizione di fare concorrenza a se stessi (il
rapporto è inversamente proporzionale: più sei presente in rete e meno
vendi, più sei assente e più vendi).
Discorso
diverso per le testate che vivono esclusivamente sul web. Tra queste, a
differenza dei siti derivati dai cartacei (che in larga misura sono
pessimi o imbarazzanti proprio per la contraddizione appena detta), ce
ne sono alcune molte interessanti che trattano temi generalisti come
arte, politica e società. Le migliori di esse sono quelle che vivono di
contributi e sponsorizzazioni di multinazionali o aziende molto grandi
(la cui presenza nei siti è quasi sempre non visibile e spesso non
esplicita) e non di raccolta pubblicitaria (perlopiù rifiutata proprio
perché emanazioni di una sola azienda). Si tratta di un nuovo modello
di “rivista” e/o blog di cui si è parlato parecchio in questi ultimi
anni: se sul loro ruolo e scopo è lecito avere dubbi e sospetti (grossi dubbi e
sospetti) a causa dell’ipotetico non limpido utilizzo della
comunicazione a fini commerciali, è indubbio che sappiano intrattenere
perché i giornalisti che ci scrivono, pagati o comunque scelti per
interesse economico, sono generalmente preparati e capaci.
Per
cui, tornando a noi, se per “cartaceo + web” intendi stampare
normalmente il giornale e tenere attivo un sito, mi dispiace ma no, non
fa per noi perché si tratta di un costo aggiuntivo che non trova alcun
riscontro nelle vendite. Diverso sarebbe tenere un sito con contenuti a
pagamento, ma mi pare che anche i pochi tentativi in questo senso non
abbiano avuto grande fortuna. Naturalmente tutto questo discorso vale
per le testate in italiano, perché quelle in inglese hanno un pubblico
potenziale enormemente più grande e quindi tutti i discorsi vanno
riformulati.
So bene come la pensi sui finanziamenti ai
giornali, d’altronde specifichi che Blow Up “… non riceve né ha mai cercato di
ricevere finanziamenti pubblici perché riteniamo indegno chiederne e
infame darne; siamo liberi di vivere unicamente delle nostre forze.” Per
te quindi non ci possono essere eccezioni, magari forme di
finanziamento più accettabili? Io su questo non sarei cosi
intransigente, credo che lo Stato possa e debba in qualche modo
stimolare e promuovere le attività culturali, d’altronde anche se in
maniera piuttosto generica lo afferma nell’articolo 9 della
Costituzione: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica”. Resto dell’idea che sarebbe il massimo
avere editori o mecenati illuminati, ma mi sa che in giro non se ne
trovano più…
Dal
numero di aprile non vedrai più quella scritta su Blow Up; i tempi sono
cambiati e i finanziamenti pubblici si sono fortemente ridotti, non
vale più la pena perdersi in cose di questo tipo. In ogni caso
l’articolo 9 della Costituzione non è una legge divina ma uno dei tanti
articoli di una delle tante costituzioni del mondo e recita che la
Repubblica italiana promuove,
non che mantiene, anche io, con Blow Up, promuovo la buona musica, la
buona letteratura e il buon cinema (spero) ma non li finanzio
personalmente: li promuovo, cioè li spingo e cerco di farli conoscere
al pubblico. Il resto tocca ai lettori, altrimenti qualunque rivista
potrebbe rivendicare, a ragione, la sua natura culturale: le finanziamo
tutte? Potrei essere d’accordo sulla necessità che lo Stato riconosca
il valore collettivo di determinate iniziative o ne promuova lui stesso
direttamente. Il problema è che forse di questa
nobile intenzione si è un po’ abusato: stento a riconoscere il valore
collettivo e “culturale” di testate che, create solo per pippare soldi
pubblici (milioni di euro, non milioni di noccioline), fanno
esattamente le stesse cose (o anche peggiori) di altre testate che si
mantengono senza prendere quei soldi. Diciamo che come minimo si tratta
di concorrenza sleale foraggiata da una politica clientelare e
parassita. In generale credo comunque che una minor ingerenza dello
Stato nelle politiche culturali, a qualunque livello, non faccia che
del bene innanzi tutto ai cittadini perché anche la cultura è, o deve
tendere ad essere, un’impresa come le altre (nessuno al mondo fa
impresa senza riscontri economici, men che meno le ONLUS o le
cooperative). Negli ultimi cento anni il Paese con il minor
interventismo statale – gli USA – ha prodotto le migliori espressioni
del cinema, della letteratura e della musica; il che non significa che
quel modello debba essere imitato, ma si tratta di un aspetto che
dovrebbe farci riflettere.
Trovi che sia sempre “diseducativo”
ascoltare la musica in streaming? Lo avevi affermato in risposta a un
lettore qualche mese fa, se non ricordo male. Possiamo però arrestare
le tecnologie secondo te? Come ci dobbiamo confrontare/comportare con
esse? Ritengo che queste abbiano vinto la loro battaglia da tempo e
condizionino sempre più le nostre esistenze (nel bene come nel male,
inutile negarlo). Io personalmente ti vedo come una sorta di partigiano
con l’elmetto che se ne sta in trincea a difendere l’ultimo baluardo
editoriale, prima che la marea montante della tecnologia invada tutto e
tutti…
Certo
che non possiamo fermare le tecnologie! Anche volendolo non sarebbe
possibile e personalmente mi ritengo tutto meno che un luddista: la
tecnologia in sé non è altro che un mezzo inanimato che agisce secondo
il comando di chi la usa. Non è la tecnologia a invadere tutto e tutti,
bensì l’uso di questa tecnologia.
È una differenza sostanziale. Io non discuto la rilevanza e
l’importanza della Rete ma il suo utilizzo. Che porta (ha già portato)
alla ridefinizione – secondo me in peggio, e qui sta certamente un
giudizio di merito – di tutte le espressioni culturali così come le
conoscevamo: giornalismo, letteratura, cinema, musica, tutto ne è
uscito stravolto. Sono convinto che anche il demenziale momento
politico che viviamo oggi (populismi, demagogie, neonazionalismi,
trumpismi, grillismi) sia figlio molto più di questo uso della tecnologia internettara che
non della crisi economica.
Ascoltare
musica in streaming (ma molto di più ascoltare musica gratuitamente)
secondo me è diseducativo rispetto a quella che considero “educazione
alla musica”: la preparazione nasce da percorsi personali di
sacrificio, dedizione, fatica, tutti elementi che qualunque facilità di
accesso (a qualunque cosa, non solo alla musica) non stimola, anzi al
contrario anestetizza. Non è una visione punitiva dell’esistenza ma una
visione politica:
ritengo che questa diseducazione (ripeto: all’ascolto, alla lettura,
alla visione, a tutto) porti gli esseri umani a un grado molto più
basso di consapevolezza, riducendoli a semplici consumatori. Ricordi i
CCCP? “Produci, consuma, crepa”. Ecco, dopo i beni materiali adesso ci
siamo arrivati anche per quelli immateriali, la “cultura”: buona parte
di ciò che si trova in rete da leggere, vedere e ascoltare è realizzato
dalle stesse persone che lo consumano trastullandosi in attesa di
crepare. Il cerchio perfetto di un sistema che, sbarazzandosi di
qualunque investimento e di ogni mediazione, stabilisce rapporti
diretti produttori-consumatori identificandoli nelle stesse persone e
traendone quindi il massimo guadagno col minimo sforzo. Il dominio
magnifico e trionfale di quello che a tutti gli effetti è il sistema
capitalistico 2.0, molto più scaltro, scafato, insinuante, presentabile
e convincente di quel rottame dell’1.0 (consiglio la lettura di Il Mondo Nuovo di
Aldous Huxley, vera distopia del presente molto più dell’ingenuo 1984 di Orwell).
L’immagine
del partigiano con l’elmetto è simpatica (dillo: avresti voluto citare
l’ultimo giapponese che combatte nella giungla ma ti sei autocensurato
J) ma non mi appartiene minimamente perché di difendere l’ultimo
baluardo editoriale, che non credo proprio sia il mio, mi frega meno di
zero. Il problema non sono io e neanche la gran parte di quelli che ci
leggono in questo momento (ci siamo formati intellettualmente in
un’altra epoca e ci è facile giudicare e distinguere) ma le generazioni
che ci seguiranno e quelle che oggi stanno inconsapevolmente
alimentando il proprio suicidio. Io non sono un giornalista, tra poco
avrò 56 anni e Blow Up gode di buona se non ottima salute, quindi del
destino dell’editoria e persino della musica stessa mi interessa nella
misura in cui mi sarà sempre più difficile leggere e ascoltare belle
cose nuove. Ma ce ne sono così tante restate indietro da ascoltare e
riascoltare, così tante da leggere o da rileggere e così tante de
vedere e rivedere che potrebbero bastarmi per il resto della vita e le
prossime tre. Ti saluto sulle note di “We’ll
Meet Again” di Vera Lynn, che a questo punto mi
pare la canzone più adatta.
Daniela Federico - Il Mucchio selvaggio
Il Mucchio Selvaggio ha una Storia gloriosa
e complessa, inutile far finta di dimenticare le polemiche nate dopo
l’uscita dell’ex direttore Stefani. Eppure la rivista è riuscita ad
andare avanti, sfogliandola si capisce bene che lo spirito è rimasto
più o meno lo stesso, e che soprattutto c’è uno sforzo grafico e di
contenuti non indifferente. Insomma i cambiamenti fanno solo bene?
A
volte sono necessari per non morire di inedia e per avere uno sguardo
aperto al futuro. È la storia del Mucchio. In ormai 40 anni ha cambiato
pelle decine di volte, cercando sempre di cogliere nuovi stimoli e
sfide.
Noto, se non vado errato, che ci sono molti
collaboratori anche piuttosto giovani…
I
giovani sono una risorsa enorme. Hanno curiosità, dubbi, incoscienza:
requisiti necessari per fare un giornale vivo.
L’indirizzo principale del giornale è più o
meno sempre legato al rock, non solo di area anglosassone. Avete mai
pensato di allargare il vostro raggio d’azione o sentite che quella è
la strada da seguire?
Credo
che sia sbagliato definire il Mucchio un giornale rock. È un magazine
“musicale” e culturalmente eterogeneo. Dentro ci puoi trovare passione
per il nostro lavoro, attenzione per ciò che riteniamo importante
comunicare, apertura verso tutte le arti che regalano emozioni e
tentano strade originali. Tutto questo avviene grazie alla
collaborazione di un nucleo di persone unito e, assolutamente, capace.
Posto che la sola copertina non fa l’intero
numero, viene da pensare che ci sia una predilezione per i nomi
“pesanti” del rock, nel 2016 avete dedicato la prima pagina a John
Carpenter, Lou Reed, Bob Dylan, David Bowie, Leonard Cohen. Il dato
spicca comunque, anche se poi ne avete date anche a gruppi più giovani.
Più in generale, conviene assecondare i gusti di un pubblico più
adulto? Il vostro com’è composto? Quale la percentuale, se avete avuto
modo di appurarlo, dei lettori che hanno meno di 30 anni?
Le
copertine si decidono mese per mese, e purtroppo la maggior parte di
quelli che hai nominato non sono più con noi. Abbiamo ritenuto giusto
che andassero in copertina. Sono stati artisti che hanno fatto la
storia della Musica e dell’Arte in generale. I lettori del Mucchio
vanno dai 16 a 60 anni, la grande maggioranza però si colloca tra i 25
e i 45. Non si tratta di accontentare gli uni o gli altri – l’età media
si è abbassata nell’arco degli ultimi cinque anni – ma di proporre
quello che ci sembra più rilevante in quel mese. Poi conta molto anche
la maniera in cui vengono sviluppati i contenuti, e quando puntiamo su
una copertina significa che siamo sicuri di poter offrire
approfondimenti di un certo livello con chiavi di lettura non scontate.
L’ultimo servizio sugli Stooges del numero di marzo, per dire, contava
sedici pagine e un lavoro di ricerca iconografica molto curato.
In merito alla questione fondi per
l’editoria, dichiarate che siete “impresa beneficiaria dei contributi
di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni”. Ho
una curiosità in proposito: riuscite a pagare tutti i collaboratori?
I
contributi per l’editoria di fatto non esistono più, come la
pubblicità. Con la vendita in edicola e gli abbonamenti riusciamo a
sostenere le spese e a pagare tutti coloro che numero dopo numero fanno
un gran lavoro. Cifre non certo alte, ma dignitose.
Quante copie vendete ogni mese? Rispetto a
dieci anni fa le vendite sono migliorate o peggiorate? Vedo che avete
anche approntato specifici pacchetti per gli abbonati, uno di questi è
comprensivo di carta + ipad + iphone + pdf.
Le
vendite sono costanti. Rispetto a dieci anni fa non c’è stato lo
tsunami, l’editoria in realtà è morta molto prima. Gli anni d’oro sono
stati gli Ottanta, poi insieme alla discografia ha iniziato il declino.
Il pdf è una soluzione che piace molto perché permette di archiviare i
numeri sul computer e di ricercare i contenuti con facilità. Mentre la
disponibilità su tablet fa sì che il Mucchio sia sempre “con te”. Il
formato si adatta alle diverse esigenze del lettore che ad oggi, ad
ogni modo, continua a preferire la carta.
Anche il sito mi sembra piuttosto
aggiornato, ma mi pare di capire che la priorità vada sempre al
cartaceo. Avete intenzione di continuare su questa strada?
Il
sito è un’appendice del giornale, non potrebbe vivere senza. Il nostro
obiettivo è di continuare a sfogliare il Mucchio. Sempre e comunque.
Rossano
Lo Mele - Rumore
Rumore quest’anno compie 25 anni, un gran
bel traguardo. Io l’ho sempre vista come una rivista che ha provato,
riuscendoci, a unire il rock nelle sue varie forme – pure quello più
heavy, senza arrivare a diventare la classica rivista metal, ovvio –
anche l’elettronica. Personalmente sono cresciuto leggendo gli articoli
di Vittore Baroni, Walter Rovere, Alberto Campo, Andrea Prevignano, che
rappresentano il passato del giornale, che intanto ha cambiato pelle,
compresi alcuni collaboratori, e si è data un taglio editoriale devo
dire piuttosto “fresco”, lavorando in particolare sulla grafica e le
rubriche. Avete anche un sito aggiornato, ma mi sembra chiaro che
puntate sempre al cartaceo. Contate di continuare così o pensate che il
futuro sia il web?
Al
netto del fatto che a un certo punto questa cosa accadrà, credo che sia
un argomento che viene dibattuto e usato molto spesso dalle persone che
questo ambiente non lo conoscono per nulla, non ne hanno idea e allora
gli sembra una cosa moderna dire che tanto questa roba morirà, e che si
passerà al digitale… Molti lo fanno per pura saccenteria, altri lo
fanno perché forse anche generazionalmente non sono preparati ad
affrontare quel mondo lì. Tutt’ora la carta – credo di poter parlare
anche a nome delle altre riviste – è il cuore economico che regge in
piedi la fragile architettura di questi gruppi editoriali. Per cui se
mi chiedi se da qui a cent’anni penso di centrare il nostro business
sulla carta, chiaramente ti dico di no, oltre al fatto che fra
cent’anni non ci sarò. Se mi chiedi se fra due o tre anni pensiamo di
chiudere la carta, assolutamente no! Oltretutto andiamo a toccare un
tema che è uno dei centri nevralgici della discussione sui giornali e
quindi ce l’ho lì in punta di penna per uno dei prossimi editoriali…
C’è una grandissima attenzione più che mai sulla carta, e forse
dovremmo anche domandarci se un gruppo che nasce editorialmente online
e in digitale come Pitchfork Media decide di passare a creare la
Pitchfork Review si siano del tutto rincretiniti o forse un senso
imprenditoriale c’è (si sono fermati da
qualche mese, dopo undici numeri, ndr). Noi in realtà puntiamo ad
andare avanti su entrambi i fronti, finché le forze economiche e le
nostre energie ce lo permettono. Sicuramente abbiamo deciso di fare da
quest’anno uno sforzo di implementazione del sito, per cui vogliamo
crescere, siamo molto ambiziosi, vogliamo arrivare a essere un sito di
riferimento in Italia sulle questioni musicali. Scontiamo il deficit di
essere partiti tanti anni dopo gli altri, stiamo puntando ad avere più
contenuti, più qualità, meno cazzate, meno clickbaiting ma pura
informazione musicale, italiana e sul resto del mondo, con una
redazione che ora si può definire tale; sulla carta la nostra idea è di
non arretrare di un centimetro. Sicuramente abbiamo cambiato pelle, nel
senso che non siamo più il giornale che c’era vent’anni fa. Quando
presi in mano questa cosa l’ho fatto con grandissimo rispetto nei
confronti della storia del giornale, ma voglio anche dire che ho
cominciato a scrivere per questo Rumore quando ero un “bambino”,
conosco il meccanismo dall’interno perfettamente. Non so quante persone
conoscano meglio di me da dentro questo giornale. Ho grande rispetto
per la sua storia, non la voglio tradire assolutamente; so che Rumore è
un tipo di giornale diverso dagli altri, una rivista che comunque deve
far emergere anche delle nuove tendenze, nel momento in cui queste
emergono soprattutto dal web, ma dobbiamo stare attenti a quello e
sapere che il nostro futuro ovviamente è anche legato alla nostra
visione del passato e a come lo abbiamo raccontato, che sono poi le
nostre radici… Però se mi si dice, “dobbiamo mantenere il giornale
ancorato a quello che era nel ‘95” io dico di no. Comunque il tempo
passa, in questo momento abbiamo un nuovo team di lavoro, che è fatto
perlopiù delle firme del passato, anche se qualcuno ha deciso di andare
via abbiamo pensato di continuare con quello spirito lì, con le
modalità di racconto della contemporaneità, che sono diverse da quelle
di vent’anni fa, e chiudo con questa cosa: venti anni fa aveva senso
per un giornale far parlare della produzione discografica, dei dischi e
tutto, non c’era altro modo di raccontare quel mondo se non con le
riviste. Oggi che la musica, la narrazione della musica è presente
ovunque, un aspetto che diventa centrale per le riviste è il dietro le quinte, il backstage della
produzione musicale, l’aspetto anche diciamo “industriale” della
musica, della comunicazione, e quindi tutto è diventato più difficile e
anche stimolante. Lasciami anche dire che quello che hai detto tu
all’inizio mi ha fatto molto piacere, perché Rumore nasce da quella
vocazione, che è una vocazione quasi impossibile, provare a cercare ciò
che è forte, rumoroso, bello in tutte le musiche, senza guardare ai
generi, ed è cosi che ci piace fare il giornale, pensare ai nostri
lettori, pensare che nel Fado o nel death metal oggi possano esserci
delle cose egualmente fighissime da cercare. Devo dire che se tu guardi
com’è fatto un sito come Pitchfork, che ho nominato prima, oggi penso
che senza saperlo sia nato sulla scia di quel tipo di visione lì,
voglio dire…
I numeri: quante copie vendete e quanti
abbonamenti fate? Rispetto a dieci anni fa la situazione è migliorata o
peggiorata?
Ovviamente
la situazione rispetto a dieci anni fa è peggiorata, preferisco non
scendere nel dettaglio dei numeri. Quello che posso confermare è che
tutti quanti in edicola abbiamo perso delle copie, e quello che posso
aggiungere è che, lo posso affermare con certezza – ho passato da poco
una giornata al distributore – è che in questo momento tra coloro che
hanno preso delle bastonate nell’ultimissimo periodo noi siamo quelli
che si stanno difendendo meglio di altri in termini di percentuali di
copie, e posso anche dirti che i giornali che hanno avuto grandi
ambizioni, grandi numeri, grandi sparate, hanno pensato di invadere il
mercato con tirature enormi o con contenuti che strizzavano l’occhio al
grande pubblico, sono quelli che in questo momento sono messi peggio di
tutti. Il nostro comparto, viceversa, comunque tiene abbastanza a
differenza degli altri. Devo dire che l’offerta in edicola è anche più
bassa rispetto a una volta, ma non è che l’offerta di testate che si è
ridotta ha fatto si che il pubblico aumentasse, spartito dalle testate
che son rimaste.
Come vedete la concorrenza in termini
qualitativi? Avete dei punti di riferimento editoriali, magari anche
esteri?
Se
rimaniamo in Italia non mi piacciono particolarmente gli altri
giornali, devo essere sincero, ma mi piacciono molto alcune firme, per
esempio trovo che sia molto bravo Stefano Isidoro Bianchi di Blow Up,
un grande scrittore, uno che ha grande visione della musica, la stessa
cosa vale per Christian Zingales, per citare due firme molto forti. Mi
piacciono più le singole unità dei giornali, mi piace molto come scrive
Damir Ivic per il Mucchio Selvaggio, me ne piacciono tanti altri, ma
molti sono amici, inevitabilmente tocca citare persone come Eddy Cilia,
Federico Guglielmi e Fabio De Luca, però nel complesso devo dire che,
ed è inevitabile, continuo a preferire il giornale che facciamo noi.
Sinceramente sono molto impallinato con l’editoria musicale straniera,
per me sin da quand’ero ragazzino è stata un punto di riferimento,
continuo a pensare che l’editoria cartacea inglese sia per noi la guida
e il riferimento in assoluto. C’era un giornale stupendo inglese negli
anni Novanta che si chiamava Select, che poi è morto. Credo che oggi
comunque quello che proviamo a fare noi sia un po’ un mix di tante
cose, tra Q, Mojo, Uncut, Wire, Pitchfork e vari altri tipi di riviste,
tipo New Musical Express per la sezione news. Perché poi ovviamente non
bisogna dimenticare che lavoriamo di fatto su due piani: uno è il
giornale cartaceo, l’altro è il sito, che è un quotidiano e quindi
comunque avendo contenuti completamente diversi destiniamo contenuti
differenti a seconda del momento. Per cui è anche inevitabile che si
guardi molto al cartaceo, quindi ai giornali che ho già detto,
stranieri, oppure che ne so, a Rock & Folk in Francia per dire,
mentre per esempio Les Inrockuptibles penso che non sia, benché fatto
bene, un riferimento per noi, perché veramente troppo legato a quel
Paese. Poi guardiamo molto ai principali nomi mondiali per
l’informazione online, quindi NME, Consequence Of Sound, Pitchfork.
Anche voi, un po’ come i concorrenti Blow
Up, Il Mucchio e Rockerilla, puntate spesso su copertine dedicate ai
nomi grossi del rock. È una scelta ben precisa? Una questione di target?
È
una scelta ben precisa perché ho scoperto mio malgrado, dirigendo il
giornale, che l’ascoltatore rock è conservatore in maniera spaventosa.
Per me questo è incredibile, perché l’ascoltatore rock io l’ho sempre
immaginato come qualcuno disposto alla novità, e non è cosi. Noi
abbiamo un impatto sulle copertine diciamo di persone consolidate della
nostra area, che arriva al 20% in più di venduto al mese, questo mese (marzo, ndr) in edicola ho realizzato
una copertina che volevo da tanto, che è Depeche Mode, non che io sia
un fan sfegatato ma riconosco una loro grande centralità nella musica
degli ultimi trent’anni e sono comunque un gruppo centrale rispetto
alla nostra idea di suono, che appassiona gran parte dei nostri
lettori. Quando abbiamo la possibilità di fare copertine del genere ci
stiamo attenti, se ci soddisfano certe condizioni, che sono il cercare
di non fare doppioni in edicola, di avere una bella intervista. Ecco,
una cosa su cui io sinceramente non transigo è che vogliamo sempre e
solo contenuti di prima mano, non costruiamo il giornale a partire da
monografie o da cosa pensa qualcuno su qualcosa, non equivale alla
nostra idea di giornalismo. Poi altri lo fanno e lo faranno anche
benissimo, però per me il confronto è la fonte diretta e attiva, la
cosa più importante di tutte, senza di quello non facciamo nulla.
Noto che rispetto alle altre riviste, Rumore
preferisce essere tendenzialmente più sintetico, sia nelle recensioni
che negli articoli di approfondimento, puntando come già accennato alle
rubriche, anche di nomi storici come Maurizio Blatto, Carlo Bordone,
Sergio Messina. Immagino siano scelte editoriali ben precise…
Penso
che alcuni tra i più bravi in circolazione li abbiamo noi. Io amo molto
anzitutto leggere le mie firme migliori, trovo che siano dei visionari
assoluti e quindi mi piace anche leggere le cose di Maurizio, che è un
amico, o Francesco, che abbiano la possibilità di esprimere un punto di
vista, o Carlo Bordone. Sono persone che sono in grado secondo me di
rappresentare da sole la forza del nostro brand mi verrebbe da dire…
Perché indipendentemente dalle mode, dai dischi che si vendono o non si
vendono, dei giornali che si vendono o non si vendono, hanno una
visione attuale, però piena di Storia, di grandi radici nella musica, e
riescono a raccontarla e a fartela vedere. Per cui si, c’è una
centralità forte perché siamo in un’epoca per cui le opinioni si fanno
sentire, specie sui social media, e se hai a disposizione qualcuno che
ha delle opinioni forti, un punto di vista forte e riesce a esprimerlo
bene, secondo me è giusto valorizzarlo. Per questo parlavo prima molto
bene di Stefano Isidoro Bianchi, perché lui secondo me è uno che ha una
grande visione, una grande capacità di lettura della musica, e quando
qualcuno è cosi, è giusto che possa esprimersi in lungo e in largo come
fa lui sul suo giornale, o come fanno queste persone sul nostro.
Il fatto che avete scelto di fare anche dei
workshop di scrittura musicale, nasce dall’esigenza di avere sempre
penne fresche?
Alcuni
dei nostri ragazzi più bravi vengono fuori da workshop in giro per
l’Italia. Per esempio il sito è quasi tutto gestito da persone su cui
ho fatto scouting durante i miei corsi. Da dieci anni insegno in
Cattolica all’Università, alcuni vengono da lì, altri invece vengono
dai workshop che faccio in giro, soprattutto su Bologna, da qualche
anno li faccio un paio di volte l’anno. Non è che ci sia un’esigenza
vera e propria, a me è stato chiesto, ho scoperto che al di là della
crisi del comparto c’è un’enorme curiosità nei confronti di questo
mondo, c’è una quantità pazzesca di persone che vogliono fare questo
mestiere, che è un non-mestiere, e lo dico subito prima mettendo le
mani avanti, però è bello confrontarsi e poter carpire qualche
strumento di lavoro per essere consapevoli nel raccontare la musica,
quindi per avere un approccio più da cronista diciamo, non da
quotidianista, ma da cronista della musica, da persona che è capace di
leggere i fenomeni e di metterli in relazione. Sicuramente è stato di
grande aiuto per noi per trovare delle persone in gamba, soprattutto
per quanto riguarda i più giovani. Sono stato molto fortunato a trovare
delle persone che lavorano per noi, con noi, di cui ho cieca fiducia,
trovo che siano il futuro e credo siano molto bravi, mi riferisco
soprattutto a Elia Alovisi, che infatti ora lavora per Noisey –
giustamente se lo sono presi – o Nicholas David Althea, loro due in
particolare devo dire che sono secondo me formidabili, sono veramente
due fuoriclasse.
Come vi vedete fra dieci anni?
Bella
domanda… molto spesso me lo chiedo anch’io. Fra dieci anni ho
l’ottimismo di pensare che noi saremo in una condizione per cui
continueremo a fare entrambe le cose, saremo più bravi a far meglio il
giornale, anche se tante cose cambieranno, e penso che il nostro sito e
i social media avranno una grandissima centralità nello scenario
italiano, al netto del fatto che dieci anni fa non avremmo neanche
nominato i social media, pensa soltanto a un dato banale: Facebook
c’era già due anni fa, sei anni fa per esempio, però l’esplosione
dell’informazione sui social media quand’è che si è avuta? Quando tutti
quanti abbiamo avuto a disposizione uno smartphone, tutti quanti
abbiamo avuto a disposizione una grande quantità di traffico dati da
poter utilizzare. Eppure Facebook c’era già prima, pensa a quanto lo
stesso mezzo con un piccolo strumento diverso in più ha cambiato
completamente la nostra ricerca d’informazioni. Poi, dal punto di vista
digitale ovviamente non sappiamo che cosa potrà capitare. Io credo che
la nostra idea è di andare avanti su entrambi i settori. Poi non so, ad
un certo punto la Gabanelli o chi per lei farà un’inchiesta e verrà
fuori che i giornali inquinano il mondo e che non bisogna più leggerli,
non so, allora faremo solo il digitale… la verità è che il digitale
oggi non muove ancora i capitali per poterci sostenere.
|