
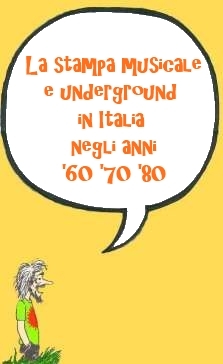
|
Dai beat a i punk. 10 anni
di controcultura a
Milano 1967-1977 1. I beat e il '68 All’alba del 12 giugno 1967 la polizia sgomberò il campeggio beat sorto in via Ripamonti, accanto al fiumicciattolo Vettabbia; il blitz delle forze dell’ordine era stato da tempo richiesto da parte dell’opinione pubblica moderata milanese, “Corriere della sera” in testa, che mal tollerava l’instaurarsi di una «New Barbonia city» – per riprendere un articolo del quotidiano milanese[4] – alle porte della metropoli, campeggio presto divenuto – secondo questa volta le parole del prefetto – «ricettacolo di elementi oziosi e vagabondi»[5]. Poco servì il fatto che i beat milanesi – «capelloni» e «sbarbine» secondo una certa stampa[6] – avessero regolarmente affittato quel terreno per un periodo che andava dal 1° maggio al 31 agosto ’67; l’azione della polizia fu inesorabile, quanto spettacolare: 79 arresti, circa 200 fogli di via e soprattutto per disinfestare la zona furono usati, secondo le cronache del tempo, 500 litri di DDT. Con lo sgombero dell’«inverecondo bivacco» (per riprendere un sottotitolo sempre del “Corriere”)[7], si può dire che terminò anche l’esperienza beat milanese[8]. Inoltre l’uscita di lì a poco del 5° numero (ma in realtà il 7° dato che i primi due furono il numero 0 e il 00) della rivista “Mondo beat” per l’editore Feltrinelli determinò una spaccatura all’interno del movimento, con alcuni “scissionisti” che risposero a tale iniziativa, considerata poco underground e molto mainstream, con la pubblicazione di un foglio alternativo (che cambiava nome ogni volta per sfuggire alle normative sulla stampa e all’obbligo del direttore responsabile usando la dizione «numero zero in attesa di autorizzazione»)[9] denominato in successione “Urlo beat”, “Grido beat”, “Urlo Grido Beat”, “Parentesi beat”. Con il ’68 alle porte, iniziò un vero proprio esodo all’interno del movimento beat, con alcuni dei suoi esponenti che partirono per l’Oriente (soprattutto India e Afghanistan)[10], mentre altri preferirono allontanarsi da Milano per dar vita a comuni in campagna, e particolarmente nota fu quella di Ovada[11]. I primi beat, di estrazione sociale per lo più proletaria, erano comparsi a Milano alla metà degli anni ’60[12], ritrovandosi dalle parti di piazzale Brescia per muovere successivamente verso il centro, e fissando il loro punto d’incontro dapprima presso la metropolitana di Cordusio e poi in piazza Duomo sotto la statua del “pirla a cavallo”, così come veniva definito il monumento a Vittorio Emanuele II nello slang beat. Nel gennaio del ’67 i beat affittarono uno scantinato in via Vicenza – presto denominato secondo suggestioni estere “la Cava” – che divenne da subito il punto di riferimento del movimento italiano. I beat si legarono ai cosiddetti provos milanesi – i situazionisti dell’“Onda verde”[13] nelle cui fila figura di riferimento è Andrea Valcarenghi, futuro fondatore di “Re Nudo” – dando vita assieme ad una serie di manifestazioni pacifiche; particolarmente riuscite risultarono quella antimilitarista del 4 novembre ’66, quella del 27 novembre ’66 contro i fogli di via, e quella del 6 maggio ’67 durante la quale vennero trascinate per il centro di Milano una serie di bare bianche e lunghe catene per protestare con la guerra in Vietnam. Nelle manifestazioni beat e provos s’intrecciavano tematiche esistenziali provenienti dal modello americano degli hippies a concrete battaglie politiche a favore di maggiori diritti civili; l’obiettivo non era certamente quello, per così dire, di prendere il potere, quanto quello di combattere con le armi underground della provocazione e della non violenza la società tradizionale[14]. Il movimento beat milanese diede vita ad un’interessante proliferazione di testate underground, fra le quali si distinsero, oltre al già citato “Mondo Beat”, “Pianeta Fresco” e “S”. Fra i 3 giornali, “Mondo beat” fu il foglio più politico[15]; nelle sue pagine si ritrovano alcuni temi portanti delle future proteste sessantottine e degli anni seguenti quali il pacifismo, l’antimilitarismo, l’obiezione di coscienza, il libero amore, il diritto al divorzio, all’aborto, alla pillola in un contesto di generale critica alla politica tradizionale – anche quella dei partiti di sinistra – ed una esaltazione della vita in comune per superare definitivamente gli stereotipi della famiglia, della società, della buona educazione tradizionalmente intesi[16]. Inoltre inizia già ad emergere quella passione per l’Oriente che influenzerà le scelte esistenziali di una parte non trascurabile della gioventù del decennio successivo. “Pianeta fresco” – nato per iniziativa della ‘madrina’ del beat italiano, ossia Fernanda Pivano (direttrice «responsabile» della rivista, mentre direttore «irresponsabile» risultava Allen Ginsberg), e il cui primo numero uscì nel dicembre del ’67 – si distinse da “Mondo beat” per un tono sicuramente più intellettuale affrontando tematiche proprie dell’underground americano quali la possibilità e la libertà di poter espandere la propria conoscenza tramite l’uso di sostante psicoattive, e un più esplicito misticismo attento ovviamente a religioni e filosofie orientali. Da “Pianeta fresco” sparivano quei concreti problemi esistenziali presenti invece su “Mondo beat”, quali la fuga da casa, la repressione da parte del sistema, il bisogno di socializzazioni alternative, mentre si parlava in termini teorici di de-condizionamento culturale, di nuove visioni apprese tramite viaggi allucinogeni. Si abbandonava la materialità della strada dove si era formato il movimento beat, per concentrarsi su happening e readings dove si venne a creare, sia pure in forma elitaria, una originale intellettualità underground[17]. In maniera simile, anche la situazionista “S”, il cui primo numero vide la luce nell’ottobre 1967, fece fare un salto di qualità da un punto di vista culturale al movimento underground non solo milanese, visto che fu diffuso anche in altre città italiane; nelle sue pagine, ricercate anche da un punto di vista grafico, vi era sì una ripresa di alcune tematiche protestatarie già comparse su “Mondo beat”, ma ora presentate secondo una prospettiva sicuramente meno elementarmente schematica; tale era ad esempio l’appello ad un’opera di deculturizzazione per difendersi dalla Cultura imposta dal sistema, tramite giochi di parole, ambiguità fra accaduto e immaginato, détournement di passata consuetudine dadaista[18]. Sempre per quello che riguarda l’attenzione della scena underground milanese all’uso di sostanze stupefacenti per finalità meditative e artistiche, va ricordato nell’ottobre del 1968 la fondazione del SIMA (acronimo di Servizi Istituto Mass-Media Art) in via Soresina 5 per iniziativa di Ignazio Maria Gallino e Guido Blumir, sull’esempio dell’esperienza inglese di Release[19], per fornire non solo una difesa medico-legale nei confronti di drogati o omosessuali in difficoltà con la legge o la società, ma per progettare anche un laboratorio di produzione psichedelica rivolto a varie arti, particolarmente attivo nei primi anni Settanta. Progetti e finalità del SIMA vengono così ribaditi sul numero zero della rivista “Get Ready” nel 1972: Nuove dimensioni, espressioni favolose. Musica per viaggiare, finzioni per ritrovare la realtà, segni e colori come allusione di un altrove dove non a tutti è possibile sparire, amplificazione della percezione, dilatazione, sinestetiche, cinema. Chi vuole trovare le chiavi per alleggerire il cemento armato della cultura europea? E realizzare in modo stroboscopico un programma che comprenderebbe mostre, sequenze musicali, teatro, cinema visionario[20]. Legato all’esperienza del SIMA fu anche la creazione dello IAP (International Alternative Press) in via Anfiteatro 9 allo scopo di alimentare un circuito per la diffusione e la distribuzione della stampa underground altrimenti destinata a scarsa, se non nulla, visibilità. Una certa continuità fra beat e contestazione sessantottesca è stata più volte messo in luce, ad esempio da Alberto De Bernardi quando scrive che «con i capelloni siamo alle origini del movimento», notando come punti di contatto soprattutto la critica alla società dei consumi e l’internazionalismo pacifista[21], o da Peppino Ortoleva quando afferma che, a livello americano ed europeo, «è ovvia la continuità fra linguaggio e stili di vita “underground” con atteggiamenti ribellistici del movimento del ’68»[22]. L’underground beat servì sicuramente a creare quell’humus dove crebbe fertile il movimento di protesta studentesco; se sono evidenti queste continuità – nell’abbigliamento, nella scelta dello stile di vita, nella critica alla società consumistica – non sono meno evidenti le rotture[23]: il ’68 fu un movimento di massa e politicizzato, che non disdegnava la violenza – sia pure spesso in chiave difensiva – e non più una ridotta “banda di capelloni”, quale era il movimento beat dedito alla semplice pratica dimostrativa della provocazione e dello scandalo, tenendosi sempre lontano da qualsiasi pratica di violenza[24]. Concretamente si può ricordare che se il terreno di via Ripamonti fu regolarmente affittato dai beat, l’anno successivo, nel novembre del ’68, l’ex Hotel Commercio di piazza Fontana, in pieno centro, appena dietro il Duomo, fu occupato da studenti che vi insediarono la Casa dello studente e del lavoratore, primo esempio di occupazioni di luoghi abbandonati, o comunque disabitati, che caratterizzeranno gli anni Settanta[25]. Questo equilibrio fra continuità e rottura nel passaggio tra il movimento underground e quello sessantottino fu così illustrato da uno dei protagonisti del ’68 europeo, Rudy Dutschke che lo paragonò a quello fra filosofia classica tedesca e marxismo: come Marx era partito da quella filosofia per costituire il suo paradigma, così il movimento studentesco si era abbeverato alle fonti dell’underground, pur superandolo, per definire meglio temi e termini della sua protesta[26]. Ma che rimanesse anche una certa diffidenza fra i due mondi è stato ben testimoniato da Silla Ferrandini nel suo romanzo autobiografico sulla beat generation milanese I fiori chiari: anche se avevamo alcune idee in comune la distanza era abissale, loro [i sessantottini] davano del borghese a noi [i beat] perché dicevano che non avevamo una vera ideologia politica, e noi davamo del borghese a loro perché di rimando dicevamo che volevano instaurare un regime altrettanto autoritario e altrettanto repressivo del capitalista[27]. 2. "Re Nudo" e Macondo Protagonista del microcosmo beat-provos milanese fu sicuramente Andrea Valcarenghi, che dopo alcuni vicissitudini carcerarie, fu il fondatore di “Re Nudo”, l’unico giornale underground che ebbe un seguito e una durata significativa che coprì l’intero decennio degli anni ’70[28]. Secondo Valcarenghi, la cultura underground si diffuse in Italia nei primi anni ’70 come risposta all’incapacità dei movimenti rivoluzionari più politicizzati di «dare una risposta al problema del superamento della scissione fra attività politica e vita privata»; di fronte ad un «problema esistenziale […] sentitissimo» dai giovani la risposta non poteva infatti limitarsi a quel «clima operaistico e militaresco» imposto dai vari gruppuscoli della cosiddetta sinistra extra-parlamentare[29]. Lo scopo di “Re Nudo”, soprattutto nei primi anni, era quello di non disperdere dopo il biennio 68-69, che aveva visto il sorgere di nuovi protagonisti sulla scena politica antisistema (ossia studenti e operai), il patrimonio ideale e culturale del movimento underground, che come abbiamo visto, anche in Italia e soprattutto a Milano aveva cercato di raggiungere una sua visibilità. Si tentò in pratica di evitare che fosse del tutto emarginata dal variegato movimento di protesta di quegli anni l’area libertaria, situazionista, trasgressiva, ossia quella sicuramente meno ideologica. Da qui le difficoltà che sempre ebbero i “renudisti” ad interloquire non solo con i partiti della sinistra della storica, ma anche con il Movimento studentesco, e altre forze della cosiddetta sinistra extraparlamentare, ormai in piena deriva verticistica, spesso dogmatica e comunque settaria. Preceduto da una particolarissima “campagna pubblicitaria” tesa a spiazzare l’opinione pubblica – i muri della città furono riempiti di scritte riportanti il nome della futura testata seguito da un punto interrogativo o da quello esclamativo – il numero zero di “Re nudo” vide ufficialmente la luce nel novembre del 1970, con una tiratura di diecimila copie distribuite principalmente a mano e andate completamente esaurite in poco tempo. Se si sfogliano i primi numeri della rivista, colpiscono i frequenti riferimenti all’underground americano: Timothy Leary (con 2 articoli nel numero 0)[30], Aldous Huxley[31], William Burroughs[32], Allen Ginsberg[33], Angela Davis[34], Kate Millet[35], John Sinclair[36] e Jerry Rubin[37] e la loro “Convenzione rivoluzionaria”[38], i Weathermen Underground[39], le Black Panthers e le White Panthers[40], i portoricani Young Lords[41] sono oggetto di approfondimenti sulle pagine del mensile a testimonianza di quale fossero i primi punti di riferimento della redazione, d’altronde questo interesse era stato ben esplicitato nell’editoriale del primo numero allorché si avvertiva che un «aspetto centrale» di “Re Nudo” sarebbe stato «l’informazione dettagliata e continua dei gruppi rivoluzionari stranieri, specialmente americani»[42]. Accanto all’interesse per il mondo protestatario americano, non mancarono sulla rivista articoli dedicati a dar voce e spazio a tutte le lotte, soprattutto a quelle considerate ancora marginali, riguardanti il nostro paese; particolare attenzione fu dedicata alla condizione delle carceri – soprattutto tramite la pubblicazione di scritti e poesie del “bandito comunista”, allora detenuto a San Vittore, Sante Notarnicola[43] – e inoltre al mondo delle tossicodipendenze, ai nascenti movimenti dell’antipsichiatria, omosessuale, femminista. Come fu scritto nel già citato editoriale del primo numero del dicembre 1970: «caratteristica fondamentale per un giornale underground italiano deve essere la denuncia organica delle istituzioni repressive dello stato: fabbrica, scuola, istituti psichiatrici, carceri»[44]. Coerentemente a questo programma, nel numero 4 di “Re Nudo” dell’aprile del 1971 furono pubblicati i primi 6 comunicati delle Brigate Rosse, che cominciavano allora le loro prime azioni nelle fabbriche lombarde: pur nutrendo delle «riserve nei loro confronti» – si legge nelle righe di presentazione – la redazione di “Re Nudo” considerava i brigatisti come dei «compagni», anche loro in lotta contro le strutture repressive delle istituzioni statali[45]. Da un questionario allegato alla rivista qualche anno dopo, nell’ottobre ’76, emergeva che politicamente i giovani lettori di “Re Nudo” si sentivano vicini alle battaglie del Partito radicale, e in misura minore a Lotta continua e all’anarchismo[46]. Nel settembre del 1973 si tenne a Milano, organizzato da "Re Nudo", un congresso, il cui titolo Oltre l’underground già mostrava le intenzioni degli organizzatori di superare una pratica di lotta minoritaria, avanguardistica, per divenire vera e propria forza controculturale in grado di saper incidere, con maggiore determinazione politica, nelle dinamiche del movimento[47]. E così, per riprendere l’icastica immagine del convegno, coniugando underground e politica, a Mao sarebbero cresciuti i capelli lunghi, ossia per riprendere le parole dello stesso Valcarenghi «oggi, all’ordine del giorno, abbiamo l’obiettivo dell’integrazione delle tematiche del movement con la lotta di classe sviluppata dalla nuova sinistra e con le battaglie per i diritti civili. Questa mediazione, questo processo in atto, il metodo e il terreno in cui ci muoviamo, si chiama controcultura»[48]. Per questi motivi, uscì come supplemento a “Re Nudo” il giornale delle "Pantere Bianche" – il nome era mutuato dalla coeva esperienza americana delle White Phanters di Sinclair – la cui volontà politica, esplicitata in un articolo già comparso nel febbraio 1972, era quella di attuare «una pratica sociale che andasse al di là di quella finora praticata ai concerti di musica rock»[49], pertanto – come ribadiva Valcarenghi – con le Pantere Bianche «l’underground serri il pugno nel saluto comunista»[50]. La storia di "Re Nudo" fu caratterizzata anche da due scissioni all’interno della redazione; la prima fu già del giugno 1971 e fu portata avanti da Gianni Emilio Simonetti e Guido Vivi, ossia le anime più neo-situazioniste del giornale – in seguito autori di pubblicazioni importanti per l’underground milanese come “Hit”, “Robinudd”, e soprattutto …Ma l’amor mio non muore[51] – che imputavano a Valcarenghi, dalle pagine del numero unico di “Re Nudo colpo di mano”, una sterile e timida attitudine, quasi riformistica, nell’affrontare i diversi problemi posti dalla realtà, quando era necessaria un’azione rivoluzionaria ad ampio spettro ben più incisiva; per usare le stesse parole degli “scissionisti”: «la lotta per l’emancipazione non può essere delegata a nessuno, ma deve essere gestita in prima persona, in maniera totale, a tutti i livelli, rompendo definitivamente con la logica della teoria e della pratica separate, riunificandole in un processo unitario inscindibile», e qualche riga sotto, per ribadire la necessità di un’azione ben più radicale, rispetto alla linea finora adottata dalla rivista, si continuava: Per quanto riguarda gli individui ai quali abbiamo sottratto il controllo del giornale, il loro ritardo teorico e la miseria della loro pratica, la loro incapacità di vivere alla velocità di radicalizzazione degli avvenimenti, hanno reso necessario che ci assumessimo il compito dell’esecuzione materiale del loro spossessamento per permettere al proletariato di riappropriarsi della sua teoria rivoluzionaria[52]. Sul numero successivo, ripreso pieno possesso della rivista anche da un punto di vista legale (pur se si ammetteva una «grande amarezza» nell’essersi rivolti alla «giustizia borghese per difendere la testata da chi, piccola minoranza militarizzata, voleva appropriarsene»), la redazione di “Re Nudo” rispondeva perentoriamente, accusando soprattutto Simonetti, di avere una «costituzione caratteriale fascista», cosa che lo aveva portato ad attuare un vero e proprio golpe – «i golpisti» è termine che ricorre nella risposta – per imporre una nuova linea editoriale tesa, nella spasmodica ricerca di una nuova «avanguardia rivoluzionaria», a snaturare le motivazioni per cui era nato “Re Nudo” con l’accantonamento dell’anima beat e studentesca “sessantottina”, caratteristica invece del giornale[53]. Un’altra “scissione” – sicuramente meno traumatica – fu quella messa in atto da alcuni “renudisti” romani, i quali al contrario, rimasti ancora legati a ideali underground di matrice mistico-hippie della fine degli anni Sessanta, non avevano condiviso il progressivo espandersi su “Re Nudo” di tematiche rivoluzionarie, dichiaratamente politiche: «perché non vogliamo controgiornali rossi ma stampa alternativa […] perché pensiamo che la risata sia un’arma affilata da usare per intero, perché non vogliamo nel nostro futuro sclerotiche dittature proletarie ma il tempo delle libere tribù dai mille colori»[54]. La risposta di Valcarenghi fu contenuta in articolo intitolato significativamente Senza fucile, niente rivoluzione per ribadire la politicizzazione in senso classista del giornale: «anche noi vogliamo le tribù dai mille colori ma vogliamo che la tribù comprenda tutta la società e perché questo succeda si deve abbattere lo stato» e pertanto, concludeva perentoriamente Valcarenghi, «alla lotta di classe non si può sfuggire se veramente si vuole fare la rivoluzione», riaffermando in questo modo «la scelta attuale di porci in rapporto dialettico con quei gruppi e quegli organismi della sinistra che stimolati dalle tematiche della controcultura e dell’underground hanno iniziato un discorso politico-culturale di tipo nuovo»[55]. Sulle differenze fra Milano e Roma, relative al movimento underground, si può fare riferimento ad una distinzione proposta da Francesco Ciaponi, che segnala come il movimento milanese andasse via via sempre più politicizzandosi rispetto a quello romano rimasto più sfrontatamente hippie e psichedelico[56]. Dall’intenzione più volte esplicitata da “Re Nudo” di creare spazi di socialità al di fuori di quelli istituzionali, che fossero in grado di aggregare i giovani secondo modelli provenienti soprattutto dalle esperienze underground americane, nacquero i grandi raduni pop, che a partire da quello milanese del 1974 prenderanno la denominazione di “Feste del proletariato giovanile”[57]. Prescindendo dal piccolo happening musicale underground, tenutosi per pochi intimi a Lacchiarella nel luglio 1971 (ossia 4 anni dopo il campeggio beat di via Ripamonti), il vero e proprio primo pop festival di “Re Nudo” si tenne a Ballabio (in provincia di Lecco) in due giorni nel settembre del 1971 radunando circa 10.000 giovani, e suonarono fra gli altri i cantautori Pino Masi e Claudio Rocchi, e i gruppi Come le foglie e Garybaldi. L’anno successivo, nel giugno 1972 e su 3 giorni, si tenne a Zerbo (in provincia di Pavia) con il doppio quasi delle presenze; sono ancora festival pre-politici, dove si sente musica, si consumano droghe leggere, si fa meditazione zen, si pratica il nudismo, e così via. Per quello che riguarda la musica vi è da segnalare a Zerbo il concerto del giovane Eugenio Finardi e di Donatella Bardi. A partire dal terzo festival, tenuto su 3 giorni presso le Alpi del Vicerè in provincia di Como nel giugno 1973, con un numero di presenze limitato da problemi organizzativi, si intende superare la mera dimensione artistico-aggregativa del festival, intesa come esibizioni di cantanti e band in un contesto di festa giovanile (dal punto di vista musicale vanno ricordati soprattutto i concerti di Franco Battiato e degli inglesi Atomic Rooster), per imprimere al raduno anche una marcata caratura politica di chiara matrice controculturale. Dal successivo, quello del ’74, i festival vengono tenuti a Milano al Parco Lambro, prendendo la denominazione – come si è detto – di “Feste del proletariato giovanile”, e caratterizzandosi sempre di più per la politicizzazione dell’evento e per un numero sempre maggiore di presenze, nonché per un cast di musicisti di primissimo livello: oltre a coloro che avevano già suonato ai primi festival (Rocchi, Finardi, Battiato) si esibiranno nelle edizioni milanesi, solo per citare i più noti, il jazzista americano Don Cherry, gli Area, la Pfm, Napoli Centrale, Giorgio Gaber, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Edoardo Bennato, Antonello Venditti, Pino Daniele, Angelo Branduardi, Alberto Camerini, Gianfranco Manfredi, Ricky Gianco. A questo proposito decisivo – secondo Bertante «catartico»[58] – per il movimento underground fu l’ultimo, quello famoso del giugno 1976. Scontri, anche violenti, all’interno delle varie anime del movimento o con la polizia; l’emergere di una rabbiosa volontà giovanile di contestare più attivamente il sistema, che non poteva più essere saziata dalla riflessività underground di “Re Nudo” e che venne presto intercettata dall’autonomia; la presenza complessiva di più di 120.000 persone, decisamente troppe per la tenuta stessa dell’organizzazione, causarono il fallimento di questa esperienza che segnò un importante spartiacque anche sulla futura incisività di “Re Nudo” presso il movimento di contestazione. Gli anni successivi, nel 1977 e nel 1978, i festival si tennero in tono minore, per usare un eufemismo, e in forma “semiclandestina” a Guello, in provincia di Como, e ad Alpicella nell’entroterra ligure in provincia di Savona, senza essere “pubblicizzati” troppo per timore di nuovi disordini. Già dai volantini di presentazione, che parlavano di cucina macrobiotica, meditazioni, yoga, massaggi zen, si può intuire la rottura rappresentata dall’ultimo festival del Parco Lambro[59]. Nell’ottica di superare la mera dimensione di rivista e di divenire un più rilevante centro di elaborazione controculturale "Re Nudo" si era anche dotato di un’ampia sede in via Maroncelli 2, dove si organizzavano happening teatrali, concerti, cineforum, conferenze, e così via; locale chiuso nel marzo 1974 in seguito ad una violenta irruzione dei carabinieri in cerca di droga; l’operazione si concluse con l’arresto di 67 persone, tutte successivamente prosciolte dall’accusa di spaccio o detenzione di sostanze stupefacenti[60]; la sede, devastata dal blitz delle forze dell’ordine, invece non verrà più riaperta. Relativamente simile si rivelò l’esperienza di Macondo[61], sorta per iniziativa di Mauro Rostagno, allora ex militante di Lotta Continua in seguito ucciso in un agguato mafioso in Sicilia nel settembre 1988. Situato in via Castefidardo 7, Macondo (nome esplicitamente tratto dal romanzo Cent’anni di solitudine di Gabriel García Márquez) era sorto nell’ottobre 1977 come un locale che si proponeva di essere un «luogo di incontro, aggregazione, comunicazione del movimento», e dove per questo scopo si trovavano «un ristorante, un bar, negozi di artigianato, un cinema, una biblioteca e poi una scuola di danza, collettivi fotografici, grafici, audiovisivi»; era, per usare le stesse parole di Rostagno, «frequentato da tutti a Milano, dai giovani, dai freaks, dalla ex nuova sinistra, da molti intellettuali, da molti democratici»[62]; a Macondo infatti potevi incontrare: gli intellettuali, i sottoproletari della cintura, i ragazzini scappati di casa a 15 anni, i radical-chic, i poveri e i ricchi, quelli delle classi alte e quelli delle classi basse e quelli che non avevano classe, c’erano donne e maschi, c’era gente che non sapeva se era maschio o femmina, gente che pensava di essere maschio essendo donna e viceversa, gente che non pensava nulla, i pazzi, gli emarginati, gli sfigati, i curiosi, chi veniva lì per parlare bene, chi per parlare male[63]. Vi si erano tenuti incontri con il filosofo André Glucksmann e lo psichiatra David Cooper, una mostra del disegnatore Moebius, un convegno di Magistratura democratica. Macondo fu anche casa editrice d’arte avendo prodotto una serie di cartelle litografiche fatte appositamente da artisti del calibro di Valerio Adami, Enrico Baj, Jean Michel Folon, Renato Guttuso, Giacomo Manzù, Luciano Minguzzi, Henry Moore e altri ancora. Va inoltre ricordato come Macondo non ebbe buoni rapporti con partiti e movimenti della sinistra milanese: il PCI, l’MLS (Movimento Lavoratori per il Socialismo), la stessa Autonomia operaia accusavano i frequentatori di Macondo di disimpegno politico[64]. In seguito ad intervento della polizia, in cerca di prove su una presunta attività di spaccio di droga nei suoi locali, Macondo venne chiuso il 22 febbraio 1978[65]. La causa scatenante l’operazione della polizia e la chiusura del locale fa data dalla distribuzione al Macondo del facsimile di un biglietto del tram con scritte che invitavano all’utilizzo dello stesso biglietto come filtro per spinelli; arrestati e rinviati a giudizio anche i protagonisti della breve esperienza di Macondo, così come quelli della sede di “Re Nudo”, furono poi prosciolti in sede processuale. 3. I Circoli del proletariato giovanile e altre esperienze controculturali degli anni '70 Fortemente connessa al contesto creato da Re Nudo fu la breve esperienza dei Circoli del proletariato giovanile[66], che durò per il biennio ’75-’76; scevri da settarismi ideologici e da vincoli dogmatici i Circoli si caratterizzarono per risultare l’ala creativa del movimento, esaltando il motivo della festa, dell’happening quale imprescindibile momento rivoluzionario[67]. Come si legge sulla loro più nota pubblicazione, intitolata significativamente, Sarà un risotto che vi seppellirà, i principali riferimenti politico-culturali dei circoli erano Marx, Mao e Dioniso[68] (successivamente vengono citate come altre fonti ispiratrici la filosofa ungherese Ágnes Heller, lo psichiatra martinicano Frantz Fanon e il generale vietnamita Giáp)[69]. Fra le attività dei Circoli, oltre all’occupazione di spazi pubblici e privati non utilizzati[70], vanno ricordate la festa di primavera del 21 marzo 1976, la caccia al tesoro del 26 settembre 1976, dove il tesoro in palio era mezzo etto di erba da fumare nascosto nel centrale Parco Sempione, vicino al Castello Sforzesco[71], e soprattutto l’“Happening nazionale del proletariato giovanile”, tenutosi all’Università degli Studi di Milano il 27-28 novembre 1976, che si concluse male con la spaccatura dei partecipanti fra una parte definita «freaks», legata ancora a visioni di vita underground e hippie, e una parte, maggioritaria, ormai dedita decisamente solo alla lotta politica, dal momento che, come recitava un loro slogan, «portare i capelli lunghi non ci basta più»[72]. Si legge infatti in un documento stilato a conclusione dell’Happening: Nel dibattito, nella festa, nei due giorni di “vivere insieme” sono emerse due concezioni radicalmente contrastanti. C’erano i reduci del Lambro, inguaribili sacerdoti del culto dello spinello che ci hanno propinato due giorni di asfissianti sbrodolate para-esistenzialiste; c’era il nuovo movimento giovanile, quello che si coagula intorno ai centri sociali, quello della lotta al caro-cinema, quello dei disoccupati organizzati. Due modi di differenti e contrastanti di concepire il movimento, il suo ruolo rivoluzionario. Gli estensori dello scritto concludevano stigmatizzando il comportamento dei primi, «a questo manipolo di cattolici travestiti da freak hanno risposto i proletari del movimento», e qualche riga sotto accusando costoro, «i destri», di non aver impedito distruzioni e saccheggi avvenute durante il convegno alla sede universitaria: «hanno permesso a un pugno di manigoldi di sputtanare l’iniziativa, devastando l’università»[73]. Rivendicando «il diritto al caviale», e non solo «alla pastasciutta»[74], per citare un altro loro famoso slogan, i Circoli furono fra i protagonisti della dura contestazione alla prima della Scala del ’76. Sempre nell’ottica di rendere “proletari” piaceri borghesi i Circoli adottarono pratiche di autoriduzione nei cinematografi di prima visione e ai concerti delle star della musica rock. Nello sforzo di divenire una voce significative all’interno della galassia extraparlamentare i Circoli si dotarono di un giornale, “Viola”, che appunto servisse da organo di collegamento fra i vari circoli[75]. La vicenda dell’underground milanese ruotò, come si è detto, in misura fondamentale attorno all’esperienza di “Re Nudo”, giornale e movimento; per limiti di spazio ci si limiterà solo a ricordare alcuni giornali, riconducibili all’underground milanese, fra i tanti che videro la luce. Si è già fatto riferimento alla figura di Simonetti e alle sue pubblicazioni; accanto a queste vanno menzionate la già citata rivista musicale “Get Ready” curata da Ines Curatolo e Barnaba Fornasetti, il cui numero zero, uscito nel 1972, arrotolato su se stesso e con la prima pagina riportante i colori della bandiera italiana, aveva le sembianze di un grande spinello; su “Get ready” si insiste sulla carica rivoluzionaria e controculturale della musica rock e di conseguenza si auspica la gratuità dei concerti; la rivista uscì con altri 4 numeri sempre nel 1972[76]. Per quello che riguarda i fumetti vanno ricordate “Puzz. Controgiornale di Sballofumetti”, nato nel 1971 per iniziativa di Max Capa (pseudonimo di Nino Armando Ceretti), il cui personaggio principale era un aggressivo uccellaccio nero, di nome Folaga, con grandi scarponi pronto sempre a mettersi ostinatamente fuori dal coro[77]; e “Insekten Sekte”, foglio psichedelico di impronta sixties disegnato da Matteo Guarnaccia, i cui 17 numeri uscirono fra il 1969 e il 1975 e venivano venduti per strada[78]. Un discorso a parte merita l’esperienza de’ “L’erba voglio”, bimestrale anti-autoritario il cui sottotitolo era “servitù e liberazione di massa”, pubblicato a Milano fra il 1971 e il 1977 per iniziativa di Elvio Fachinelli e Lea Melandri. La rivista uscì sull’onda della partecipata discussione che aveva suscitato la pubblicazione per Einaudi dell’omonimo libro L’erba voglio in cui erano raccolte varie testimonianze ed esperienze relative all’educazione negli asili, scuole elementari e medie da parte di insegnanti che rifiutavano metodi autoritari; si trattò di un vero e proprio “successo” editoriale con cinquantamila copie vendute e cinque ristampe consecutive[79]. Dal libro al giornale cambiò il sottotitolo; da «pratica non autoritaria nella scuola» a «servitù e liberazione di massa», ciò non significava l’abbandono della tematica scolastica ma il voler estendere l’antiautoritarismo a più ampi ambiti, «dalle istituzioni più direttamente interessate alla formazione ideologica, a tutti i momenti della vita sociale in cui si riproducono i meccanismi di soggezione al potere»[80]; e pertanto nella rivista si parlava, oltreché di educazione, anche di antipsichiatria, di femminismo, di antimilitarismo e altri temi declinati in maniera controculturale[81]. 4. Punk A Milano, il punk arrivò presto, già nel 1977, facendo però fatica a trovare un proprio spazio nei movimenti giovanili, in quel preciso momento interessati a ben altre metodologie di lotta politica; ancora per tutti gli anni finali del decennio nella nostra città il punk non era certamente un movimento strutturato, lo diventerà nei primi anni ottanta con l’esperienza dello spazio occupato Virus di via Correggio 18. Le difficoltà del movimento punk a Milano in quel suo primo anno di esistenza sono bene evidenziate da uno dei protagonisti, Marco Philopat, nel suo romanzo autobiografico: è un periodo molto strano – ci sono molti conoscenti interessati a cambiare aria e vedono in noi punk una via d’uscita – molti altri sono scettici – sostengono che non possiamo durare a lungo conciati come siamo – si moltiplicano le provocazioni nel tentativo di far venire a galla la nostra ingenuità – soprattutto l’autolesionismo di cui blaterano i giornali sul tipo spille da balia nelle guance[82]. Inoltre, come ricorda sempre Philopat, da parte dei movimenti politici di sinistra vi è un forte «pregiudizio» nei confronti dei punk; vi è una certa errata identificazione, soprattutto da parte della cosiddetta intellighenzia di sinistra, fra punk e fascismo; il gusto della provocazione, che fa sì che alcuni accessori del look punk e alcuni rimandi “etimologici” in canzoni e nomi delle band siano presi dal “guardaroba” di un perfetto nazifascista, viene scambiato per adesione ideologica: «c’è un pregiudizio diffuso tra i compagni più vecchi – dicono che i punk sono fascistelli – i vestiti neri e le svastiche sono le prove»[83]. Ha sottolineato a questo proposito Diego Curcio, come per buona parte della sinistra «una sorta di sdoganamento» al punk avvenne nel solamente 1979 con i concerti di Iggy Pop e successivamente di Patti Smith alla Festa dell’Unità di Firenze; dopo questi importanti eventi «i giovani borchiati e dai capelli colorati non vengono più considerati dei semplici teppisti o dei fascisti da perseguitare, ma dei ragazzi eccentrici che stanno dalla parte ‘giusta’»[84]. Nei primi anni il punk milanese appare più come un insieme di singole sensibilità, di «aggregazioni informali, di strada», secondo la definizione di Beppe De Sario, che nota come nel capoluogo lombardo i giovani punk «per la gran parte provengano da un retroterra sociale operaio e popolare, emergente dall’ambiente dell’emigrazione meridionale che ha investito specialmente le nuove periferie milanesi nel corso degli anni ’50 e ’60», e come comincino a gravitare nel centro città «per attività legate allo svago, alla frequentazione di locali, circoli politici e concerti»[85]. Secondo Claudio Pescetelli, la nascita di una scena punk milanese appare invece frammentata in 4 livelli assai diversi fra di loro. I primi due, per la verità, hanno finalità meramente commerciali; c’è infatti un tentativo da parte del mercato discografico di ripetere i successi di vendita di gruppi inglesi come i Sex Pistols, e quindi si tenta, per la verità con scarsissimi risultati, di creare un mercato musicale punk “autarchico” (Chrisma, Decibel, Incesti); analogamente vi sono stilisti che, strizzando l’occhio a Vivienne Westwood, cercano di proporre sul mercato una moda “punk” (ci si riferisce soprattutto allo stilista Elio Fiorucci); ma accanto a questi progetti meramente speculativi (l’autore definisce «disprezzabile» soprattutto il secondo) vi è anche la lenta nascita di un microcosmo punk, destinato in breve tempo a politicizzarsi, che inizia a prendere contatto con i settori più libertari della scena politica milanese (mentre da altri, come si è già visto, e soprattutto da Movimento Lavoratori per il Socialismo sarà osteggiato perché reputato “fascistoide”, come ricorda Tiberio uno dei primi punk milanesi)[86] in modo da poter trovare spazi aggregativi – che non fossero il negozio di dischi New Kary di via Torino o il sabato alla Fiera di Senigallia – di formazione e di diffusione della controcultura punk (il centro sociale Santa Marta nell’omonima via centrale di Milano fu il primo a ospitare i punk nella sua sede); e poi c’è un’anima artistico-situazionista, che avrebbe trovato un proprio spazio performativo presso il locale autogestito Vidicon, e che aveva precedentemente dato vita alle iniziali fanzine punk milanesi: la prima di queste, uscita già nell’ottobre del ’77, si chiamava “Dudu” e venne stampata in 1000 copie, per poi trasformarsi nel gennaio dell’anno successivo, con il secondo numero (in tutto verranno pubblicati 6 numeri) in “Pogo”, sulle cui pagine compaiono le prime traduzioni dei testi delle band punk inglesi. Nel marzo del ’79 viene dato alle stampe “Xerox” (la rivista viene infatti interamente stampata con la fotocopiatrice) per iniziativa della punk milanese Rosso Veleno; rivista che oltre a dedicare spazio alla ben più consistente scena punk inglese, inizia a occuparsi anche di punk italiano, e soprattutto milanese[87]. E a Milano, il 9 dicembre 1978 alla Palazzina Liberty nel parco di Largo Marinai d’Italia, si terrà il primo festival punk italiano, peraltro poi chiusosi in anticipo causa frequenti litigi fra le band e il pubblico: «non certo un successo, ma pur sempre un evento fondamentale» per la storia milanese di questo movimento[88]. Come ha notato sempre Pescetelli, quello della fine degli anni ’70 sarà una sorta di «rodaggio» per il movimento punk milanese, che poi si esplicherà al meglio delle sue potenzialità controculturali ribelli nei primi anni del decennio successivo: «esattamente come accadde nel 1966 con il movimento beat, anche il punk iniziò a cementarsi attraverso un percorso di autorappresentazione e un costante nomadismo che gli permise di radicarsi gradualmente nel tessuto urbano»[89]; anche se, come ebbero giustamente a notare Nanni Balestrini e Primo Moroni, i tempi del presente e le prospettive per il prossimo futuro della società erano profondamente mutate, in negativo, sotto ogni aspetto, e pertanto: I giovani che vengono sulla scena dopo il ’77 sono in effetti ben diversi da quelli che li avevano preceduti; essi sono gli spettatori del crollo dei miti sociali del moderno: la crisi di prospettiva della società moderna appare loro come il venir meno di ogni possibilità di futuro. Il punk è, in questo senso, la lucida consapevolezza di un mutamento epocale[90]. Dai beat ai punk, dal ’67 al ’77, Milano si era comunque popolata, in maniera caleidoscopica e continuativa, di giovani, di pubblicazioni, di iniziative, di concerti, di manifestazioni, di luoghi d’aggregazione e così via che fornirono una sicura vivacità underground e controculturale alla città, «una storia sublime e tragica» come fu già ai tempi definita[91]; una storia composta da momenti a loro modo importanti per la Milano contemporanea, e che probabilmente meritano ulteriori approfondimenti storiografici. Note 1 Ignazio Maria Gallino (a cura di), 1965-1985 Venti anni di contocultura. Frammenti storici dell’underground italiana, Milano, Ignazio Maria Gallino editore, 2016; i due passi citati si trovano nel risvolto di copertina. Questo libro è ovviamente imprescindibile per chiunque voglia affrontare le controculture italiane e qui citato, per così dire, “una volta per tutte”; via via nelle note seguenti saranno segnalati altri studi e saggi relativi ai temi affrontati nel saggio. 2 Primo Moroni, Il movimento beat e i suoi giornali, in “Gli anni affollati”, 1984; ora in Gallino (a cura di), 1965-1985 Venti anni di contocultura, cit., p. 35. 3 Per una guida coeva al decennio trattato della Milano underground e controculturale si veda, Giuseppe Ricci, Claudio Marras, Mauro Radice, Milano alternativa. Frammenti di controcittà, Milano, SugarCo, 1975. 4 «La si potrebbe chiamare, tanto per usare quel loro gergo infarcito di americanismi, “New Barbonia”: è una tendopoli che sorge in fondo a via Ripamonti, al Vigentino […] È un vero e proprio villaggio beat con una trentina di tende e una popolazione fluttuante di capelloni», Un villaggio di capelloni sulle rive del Vetabbia, in “Il Corriere della Sera”, 17 maggio 1967, p. 8; e ancora qualche giorno dopo, «“New Barbonia”, la tendopoli beat […] non è soltanto un villaggio di anonimi vagabondi, di zazzeruti filosofi dell’ultima anarchia, di neo barboni che hanno fatto dell’ozio un’abulica forma di religione. È anche un ricetto per quei giovanissimi sbandati che, scappando di casa, inseguono le chimeriche visioni di vita facile, con conseguenze quasi sempre amarissime», Incursione di genitori disperati tra i capelloni di “Nuova Barbonia”, in “Il Corriere della Sera”, 24 maggio 1967, p. 8; in un altro articolo, il giorno prima dello sgombero in occasione di un primo scontro con la polizia si riportava come fosse frequentato da «capelloni, neoninfette, provos e diseredati del genere», e si paragonava la reazione dei beat milanesi alla perquisizione delle forze dell’ordine a quella «brutale e pericolosa dei mods e dei rockers inglesi», Furibonda battaglia tra polizia e capelloni stanati dal villaggio beat di Nuova Barbonia, in “Corriere della Sera”, 11 giugno 1967, p. 8. 5 Citato in Guido Crainz, Il paese mancato: dal miracolo economico agli anni Ottanta, Roma, Donzelli, 2003 p. 195. 6 Guido Pfeiffer, Ho vissuto con capelloni e sbarbine in una tenda di Barbonia City, in “La Notte”, 30 maggio 1967, p. 6; secondo l’autore dell’articolo il campeggio beat era frequentato da «questi giovani strani e queste libere, sfrenate ragazzine scappate di casa». 7 Raso al suolo dalla polizia il villaggio “beat” di Nuova Barbonia, in “Il Corriere della Sera”, 13 giugno 1967, p. 8. 8 Silvia Casilio, Una generazione d’emergenza. L’Italia della controcultura (1965-1969), Firenze, Le Monnier, 2013, p. 118. 9 Nanni Balestrini, Primo Moroni, L’orda d’oro 1968-1977. La grande ondata rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale, Milano, Feltrinelli, quinta edizione riveduta, 2008, p. 101. 10 Su alcune di queste traiettorie biografiche si veda soprattutto Matteo Guarnaccia, Underground italiana. Gli anni gioiosamente ribelli della controcultura, Milano, ShaKe, 2011. 11 Daniela Calanca, Gruppo e famiglia, in Paolo Sorcinelli, Angelo Varni (a cura di), Il secolo dei giovani. Le nuove generazioni e la storia del Novecento, Roma, Donzelli, 2004, pp. 175-178. 12 Sui beat milanesi, oltre ai testi già citati in altre note, si veda il romanzo biografico su Melchiorre Gerbino, uno dei rappresentanti più in vista del movimento assieme a Vittorio Di Russo e Marco Tiboni, di Marco Philopat, I viaggi di Mel, Milano, ShaKe, 2004. 13 Il nome “Onda verde” viene dal movimento pacifista americano “Green Wave” in cui militava fra gli altri Joan Baez, cfr. Tiziano Tarli, Beat italiano dai capelloni a Bandiera Gialla, Roma, Castelvecchi, 2007, p. 117. 14 Si veda soprattutto Matteo Guarnaccia, Beat e Mondo Beat. Chi sono i beats, i provos, i capelloni, Roma, Stampa alternativa, 2005. 15 I numeri della rivista sono stati ripubblicati in Gianni De Martino, Marco Grispigni, I capelloni. Mondo beat, 1966-1967. Storia, immagini, documenti, Roma, DeriveApprodi, 1997, pp. 59-240; e successivamente in forma anastatica in un CD allegato a Capelloni & ninfette: Mondo beat, 1966-1967: storia, immagini, documenti, a cura di De Martino, Milano, Costa & Nolan, 2008. 16 Questi motivi di dissenso e di malessere da parte dei giovani nei confronti della società di allora si possono leggere anche in Sandro Mayer (a cura di), Lettere dei capelloni italiani, Milano, Longanesi, 1968. 17 Così Fernanda Pivano, nel 1976, ebbe modo di ricordare la breve ma seminale esperienza della sua rivista: «la stagione di “Pianeta Fresco” finì senza morire, con la proposta di decondizionamento e comunicazione valide per sempre, con la certezza della esigenza di Diritti Civili caparbiamente difesa, con la speranza o il sogno o l’utopia di repressioni e di eccidi evitati se il capitale fosse stato evitato, con l’immagine di un mondo pulito, di gente pulita, di consapevolezze pulite. “Pianeta fresco” fu questo e peggio per i pochi di noi che in quella speranza/sogno/utopia hanno creduto», C’era una volta un beat. 10 anni di ricerca alternativa, Milano, Frassinelli, 2003, p. 118 (prima ed. 1976). 18 Pablo Echarruen, Claudia Salaris, Controcultura in Italia 1966-1977. Viaggio nell’underground, Torino, Bollati Boringhieri, 1999, pp. 73-81. 19 Sull’esperienza britannica di Release si veda Mario Maffi, La cultura underground, Bologna, Odoya, 2009, pp. 96-97. 20 Citato in Echarruen, Salaris, Controcultura in Italia 1966-1977, cit., p. 141. 21 Alberto De Bernardi, Il sessantotto italiano, in Marcello Flores, De Bernardi, Il sessantotto, Bologna, il Mulino, 2003, p. 172. 22 Peppino Ortoleva, Saggio sui movimenti del 1968 in Europa e in America, Roma, Editori Riuniti, p. 34. 23 Nota ad esempio Diego Giachetti, «quella del movimento studentesco […] era una protesta che pur ponendosi per molti aspetti in continuità con quella dei capelloni e dei beat, aveva caratteristiche più marcate, tali da decretare la fine di un periodo e l’inizio di uno nuovo», Anni sessanta comincia la danza. Giovani, capelloni, studenti ed estremisti negli anni della contestazione, Pisa, BFS, 2002, p. 170. 24 Casilio, Una generazione d’emergenza, cit., pp. 153-155. E come ha notato Luca Gorgolini, se i beat «erano propugnatori di una cultura alternativa (controcultura) protesa ad abbandonare il sistema piuttosto che modificarlo radicalmente, gli aderenti al movimento studentesco esprimono una “cultura del conflitto”, antagonistica, che mira ad abbattere il sistema stesso», Un mondo di giovani. Culture e consumi dopo il 1950, in Paolo Sorcinelli (a cura di), Identikit del Novecento. Conflitti, trasformazioni sociali, stili di vita, Roma, Donzelli, 2004, p. 342. 25 John Martin, Primo Moroni, La luna sotto casa, Milano, ShaKe, 2007, pp. 124-125. 26 Rudy Dutschke, La ribellione degli studenti, Milano, Fetrinelli, 1968, p. 72; Diego Giachetti giudica il parallelismo «un po’ ardito ma senz’altro efficace», Anni sessanta comincia la danza, cit., p. 193. 27 Silla Ferrandini, I fiori chiari. Il romanzo della beat generation milanese dal ’66 al ’69, Milano, OTMA Edizioni, 2006, p. 92; i fiori chiari evocati nel titolo sono un riferimento a via Fiori Chiari, che si trova nel quartiere Brera di Milano, altro luogo di frequentazione beat in quegli anni. 28 Sulla vicenda complessiva di “Re Nudo” si rimanda soprattutto alla monografia di Alessandro Bertante, Re Nudo. Underground e rivoluzione nelle pagine di una rivista, Rimini, NdA press, 2005. 29 Andrea Valcarenghi, Underground: a pugno chiuso, Rimini, NdA press, 2007 (prima ed. 1973). 30 Timothy Leary, una fuga rivoluzionaria, in “Re Nudo”, a. I, n. 0 novembre 1970, p. 7; La nuova mistica di Timothy Leary, in “Re Nudo”, a. I, n. 0 novembre 1970, p. 10; Lettera di Timothy Leary, in “Re Nudo”, a. I, n. 1 dicembre 1970, p. 2. 31 Huxley da intellettuale a visionario, in “Re Nudo”, a. I, n. 1 dicembre 1970, p. 9. 32 William Burroughs “l’ultimo scrittore”, in “Re Nudo”, a. II, n. 5, maggio 1971, pp.12-13. 33 Allen Ginsberg contro porci, anfetamine e sistema, in “Re Nudo”, a. III, n. 10, gennaio-febbraio 1972, p. 12. 34 Angela Davis, in “Re Nudo”, a. I, n. 0 novembre 1970, p. 11. 35 Kate Millet, Un manifesto per la rivoluzione, in “Re Nudo”, a. II, n. 3, marzo 1971, pp. 16-17. 36 John Sinclair, Rock +Guerra di popolo contro la musica e la classe dei padroni, in “Re Nudo”, a. III, n. 10 gennaio-febbraio 1972, p. 6. 37 Jerry Rubin, Liberato il compagno J. Sinclair, in “Re Nudo”, a. III, n. 11 marzo 1972, pp. 8-9. 38 Revolutionary People’s Costitucional Convention, “Re Nudo”, a. I, n. 1 dicembre 1970, p. 14. 39 Bernardine Dohrn, Weather Undeground. Usciamo alla luce del sole e uniamoci alle masse, in “Re Nudo”, a. II, n. 4 aprile 1971, pp. 10-12. 40 Programma politico delle White e Black Panthers, in “Re Nudo”, a. I, n. 1 dicembre 1970, p. 15; Intervista con George Jackson prima dell’assassinio, in “Re Nudo”, a. II, n. 9, novembre-dicembre 1971, pp. 14-16. 41 Young Lords da teppisti a rivoluzionari, in “Re Nudo”, a. II, n. 2, gennaio-febbraio 1971, pp. 16-17. 42 Editoriale senza titolo, in “Re Nudo”, a. I, n. 1, dicembre 1970, p. 3. 43 Sante Notarnicola “bandito”, in “Re Nudo”, a. I, n. 0, novembre 1970, pp. 14-15; Dichiarazione di Sante Notarnicola, in “Re Nudo”, a. II, n. 8, ottobre 1971, p. 16; Il “bandito” è diventato comunista, in “Re Nudo”, a. II, n. 9, novembre-dicembre 1971, pp. 10-11. 44 Editoriale senza titolo, cit., p. 3. 45 Brigate Rosse: comunicati nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, in “Re Nudo”, a. II, n. 4 aprile 1971, p. 9. 46 Mino Monicelli, L’ultrasinistra in Italia, 1968-1978, Bari, Laterza, 1978, p. 76. 47 Relazione di Re Nudo al 1° Convegno nazionale “Oltre l’underground”, in “Re Nudo”, a. IV, n. 21 settembre 1973, p. 2. Altre relazioni si possono leggere in Interventi dal primo “Oltre l’underground”, ivi, nn. 22-23, novembre 1973, pp. 2-6. 48 Valcarenghi, Underground, cit., p. 120. 49 Cosa vogliamo e perché nascono le Pantere Bianche di Re Nudo, in “Re Nudo”, a. III, n. 10, gennaio-febbraio 1972, pp. 3-4. 50 Valcarenghi, Underground, cit., p. 134. 51 Gianni Emilio Simonetti, Riccardo Sgarbi, Guido Vivi, …Ma l’amor mio non muore, Roma, Arcana, 1971; successive riedizioni Roma, Castelvecchi, 1997; Roma, DeriveApprodi, 2008. 52 Uaauuu!!!, in “Re Nudo colpo di mano”, a. II, n. 6 (n.1 nuova serie) giugno 1971, p. 3. 53 Sulla miniscissione. Chiudiamo l’argomento, in “Re Nudo”, a. II, n. 7 settembre 1971, p. 3. 54 Lettera di alcuni amici romani che sono usciti da Re Nudo, in “Re Nudo”, a. III, n. 10, gennaio-febbraio 1972, p. 8. 55 Senza fucile niente rivoluzione. Risposta alla lettera di alcuni fratelli romani, in “Re Nudo”, a. III, n. 10, gennaio-febbraio 1972, p. 8. 56 Francesco Ciaponi, Underground. Ascesa e declino di un’altra editoria, Milano, Costa & Nolan, 2007, p. 143. 57 Su questi festival si veda soprattutto Matteo Guarnaccia, Re Nudo pop & altri festival. Il sogno di Woodstock in Italia, Milano, Vololibero, 2010; inoltre il dialogo fra Francesco Schianchi, uno degli organizzatori dei festival, e Franz Di Cioccio, batterista della Premiata Forneria Marconi, in LibroLambro. I festival giovanili, sogni e utopie di ieri per oggi, Milano, Aereostella, 2013. Un particolare della locandina della sesta Festa del proletariato giovanile (Milano, Parco Lambro, 26-29 giugno 1976) è riportata nell'immagine di apertura di questo articolo. 58 Bertante, Re Nudo, cit., p.162. «Giro di boa» è il termine usato da Martin per sottolineare come dopo questa Festa, «si trasformano anche i vecchi Circoli del Proletariato Giovanile, svuotatisi dopo la crisi», per ricomparire nel novembre dello stesso anno con denominazioni, finalità e metodologie diverse, spianando la strada al ’77; La luna sotto casa, cit., p. 154. Diversa la interpretazione di Marisa Rusconi di poco posteriore ai fatti: il Parco Lambro non fu «l’ultima festa del movimento», ma semmai un necessario momento di passaggio, infatti «dallo sfacelo del mito di un certo modo di stare assieme» si passò ad altre forme di aggregazione giovanile, quale quella di Bologna nel settembre 1977, dove ci fu «un festival senza orchestre e divi pop-rock, senza danze collettivi e girotondi di corpi nudi sotto la pioggia, ma con lunghi e anche gioiosi cortei, canti e slogan» e con «un’intera città per palcoscenico, anziché un recinto grande molti chilometri, ma pur sempre ghetto dell’emarginazione e dell’autoemarginazione, un parco spelacchiato, e ricoperto di rifiuti, ai margini della metropoli», concludendo appunto che «la manifestazione di Bologna è stata la giusta risposta al fallimento del Parco Lambro […] nel passaggio dalla politica della festa alla festa della politica», Introduzione a Franco Ortolani, La Festa del Parco Lambro. Libro fotografico, Padova, Mastrogiacomo editore, pp. 4-5, 15. 59 "Dalle centomila solitudini del Lambro alla aggregazione con se stessi di Guello" è il significativo titolo del capitolo in cui Valcarenghi ebbe modo di trattare i festival da lui organizzati; Non contate su di noi. Note critiche su: movimento giovanile, violenza politica, ideologia, sessualità, droga e misticismo, Roma, Aracne, 1977, p. 42. 60 Bertante, Re Nudo, cit., pp. 142-143. 61 Su Macondo si veda soprattutto Mauro Rostagno, Claudio Castellacci, Macondo. La storia del “luogo magico” di Milano nel racconto del suo principale protagonista, Milano, SugarCo, 1978. 62 Ivi, pp. 41-45. 63 Ivi, pp. 82-83. 64 Come ricordò lo stesso Rostagno: «non avevamo contro solo certa gente, ma anche certa sinistra. Il fatto che io non facessi più politica, in alcuni ambienti della sinistra, era considerato un tradimento. Non ero più un “compagno”. Scrivevano sui muri: “Rostagno prima ci davi la linea ora ci dai il vino» (ivi, p. 91). 65 Si veda a questo proposito il numero unico di “Macondolore-Macondolcezza”, 1978, che così denunciava l’irruzione della polizia: «quello che si vuol colpire è un centro di incontro e di produzione artistica e culturale. A questi signori non garba che a Milano esista un luogo dove i giovani possano costruirsi un’alternativa alla disperazione dell’eroina e allo squallore mortale di questa città fatiscente». 66 Balestrini, Moroni, L’orda d’oro 1968-1977, cit., p. 512. 67 Come auspicava lo stesso Valcarenghi nel 1977 «le feste si moltiplicheranno, ogni quartiere ha la sua, ogni sabato ai centri sociali, feste su feste. Il dover divertirsi diventa una forma di militanza, una sorta di dover essere sotto nuova forma», Non contate su di noi, cit., p. 13. 68 Sarà un risotto che vi seppellirà. Materiali di lotta dei Circoli proletari giovanili di Milano, Milano, Squilibri edizioni, 1977, pp. 10-11. 69 Ivi, p. 13 e p. 125. 70 Si veda a questo proposito Claudia Sorlini (a cura di), Centri sociali autogestiti e circoli giovanili, Milano, Feltrinelli, 1978. 71 Sarà un risotto che vi seppellirà, cit., pp. 74-77. 72 Ivi, p. 137. 73 Ivi, pp. 99-100. Alcuni interventi al Convegno si possono leggere in appendice a Gabriele Martignoni, Sergio Morandini, Il diritto all’odio. Dentro/fuori/ai bordi dell’area dell’autonomia, Verona, Bertani, 1977, pp. 391-423. 74 Sarà un risotto che vi seppellirà, cit., p. 108. 75 Ivi, pp. 119-120. 76 Echarruen, Salaris, Controcultura in Italia 1966-1977, cit., pp. 151-152. 77 Ivi, pp. 189-191. 78 Ivi, pp. 194-195; di recente, alcune tavole della rivista sono state ripubblicate in Matteo Guarnaccia, Cosmic playground. Hippy happy life scenes. Insekten Sekte remix 1969-1975. Disegni e tracce dall’Underground, Milano, Jubal editore, 2003. 79 Elvio Fachinelli, Luisa Muraro Vaiani, Giuseppe Sartori (a cura di), L’erba voglio. Pratica non autoritaria nella scuola, Torino, Einaudi, 1971. 80 Lea Melandri, Antiautoritarismo e permissività, in “L’erba voglio”, a. II, nn. 3-4 febbraio 1972, p. 24. 81 Sulle tematiche trattate nella rivista si veda soprattutto Lea Melandri (a cura di), Il desiderio dissidente: antologia della rivista “L’erba voglio” 1971-1977, Milano, Baldini & Castoldi, 1998. 82 Marco Philopat, Costretti a sanguinare. Il romanzo del punk italiano 1977-1984, Torino, Einaudi, 2006, p. 25. 83 Ivi, p. 11. 84 Diego Curcio, Rumore di carta. Storia delle fanzine punk e hardcore italiane dal 1977 al 2007, Genova, Redazione, 2007, p. 17; l’autore ricorda come Patti Smith fu accolta con tutti gli onori da una delegazione del PCI con Achille Occhetto in testa. 85 Beppe De Sario, Resistenze innaturali. Attivismo radicale nell’Italia degli anni ’80, Milano, Agenzia X, 2009, p. 90. 86 Riferendosi proprio al ’77 Tiberio ricorda: «c’erano gli stalinisti del MLS che quando potevano metterti le mani addosso lo facevano più che volentieri: il punk per loro rappresentava una minaccia. Dicevano che il punk era fascista, perché aveva il giubbotto di pelle e i capelli corti. Ma in verità, secondo me, capivano e percepivano benissimo cosa stava succedendo, sentivano anche loro che i tempi cambiavano veloci e che con i loro slogan, invecchiati precocemente, non sarebbero andati molto lontano. Li avevamo superati in freschezza e genuinità», Tiberio, Il pogo dei Jumpers, in Marco Philopat (a cura di), Lumi di punk. La scena italiana raccontata dai protagonisti, Milano, Agenzia X, 2006, p. 104. In questo stesso libro, riferendosi sempre ai rapporti fra punk e movimenti politici coevi, Cristina Xina puntualizza come furono «gli anarchici e i libertari» a «comprendere meglio la nostra attitudine, la nostra voglia di usare lo strumento-arte come forma di ribellione» senza rifarsi necessariamente al «volantino, megafono, striscione», Laboratori di sovversione culturale, pp. 110-111. 87 Claudio Pescetelli, Lo stivale è marcio. Storie italiane, punk e non, Roma, Rave up books, 2013, pp. 145 e ss. Gli indici dei 7 numeri di “Xerox” (del n. 8 esistono solo alcune bozze mai completate) si possono leggere in Curcio, Rumore di carta, cit., p. 37-38. 88 Pescetelli, Lo stivale è marcio, cit., p. 153. 89 Ivi, p. 143. 90 Balestrini, Moroni, L’orda d’oro 1968-1977, cit., p. 629. 91 Ricci, Marras, Radice, Milano alternativa, cit., p. 126. |
